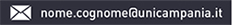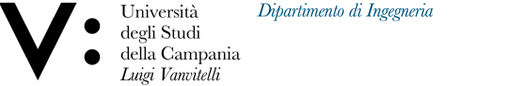Il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli è impegnato in numerose attività di ricerca nazionale ed internazionale.
Advanced Applications, Modeling and Design of Low Frequency Electromagnetic Devices - Applicazioni avanzate, modellazione e progettazione di dispositivi elettromagnetici in bassa frequenza
Descrizione linee di ricerca:
Energy Harvesting: la linea di ricerca è focalizzata sulla progettazione e ottimizzazione di circuiti elettronici di potenza e tecniche di controllo per sistemi di energy harvesting. La progettazione e l'ottimizzazione di tali circuiti e tecniche è finalizzata allo sfruttamento ottimale dell'energia fornita dagli harvester per la sua conversione ottimale in energia elettrica e l'immagazzinamento dell'energia convertita in batterie o supercondensatori. Esempi di sistemi di energy harvesting considerati sono: sistemi di energy harvesting da vibrazioni, sospensioni rigenerative, zaini rigenerativi, sistemi di energy harvesting da gocce di pioggia, sistemi di energy harvesting basati su flussi d'acqua. Numerosi articoli scientifici, brevetti nazionali e internazionali sugli harvester da vibrazioni e vari premi dimostrano l’impegno profuso dal gruppo di ricerca nel campo dell'energy harvesting.
Energie Rinnovabili: la linea inquadra le attività di ricerca sulle diverse fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento alla Fusione Nucleare e alla Conversione Fotovoltaica. La tecnologia della fusione è stata attivamente studiata dai membri del team, ottenendo risultati nella valutazione dell'impatto delle tolleranze sulle prestazioni dei reattori a fusione, come documentato da numerosi articoli su riviste e dalla citazione del contributo del team nei rapporti dell'Organizzazione ITER. Per quanto riguarda i sistemi fotovoltaici, è stato scritto un elevato numero di articoli scientifici e di brevetti principalmente relativi alle tecniche di inseguimento del punto di massima potenza (MPPT). Inoltre, in collaborazione con l'Università di Jaen e con l'Univ. di Napoli “Federico II”, è stato messo a punto un modello per simulare l'evento di un fulmine indiretto su array fotovoltaici.
Modelli Elettromagnetici Avanzati per la Fusione Termonucleare Controllata: La linea di ricerca comprende diverse attività nella modellazione elettromagnetica del plasma e dei principali componenti delle macchine a fusione, così come nelle applicazioni elettromagnetiche al CTF. Le principali attività scientifiche comprendono la modellazione elettromagnetica del plasma per applicazioni diagnostiche e di controllo, il calcolo di campi 3D in geometria complessa in presenza di non linearità, anche combinati in modelli MHD, il controllo della forma e della posizione del plasma, l'analisi di scenario e ottimizzazione, analisi delle deformazioni dei magneti e calcolo dei relativi campi di errore, modellazione delle interazioni campo magnetico-plasma e relativa analisi di impatto su equilibrio e stabilità, tecniche per l'identificazione di plasmi 2D e 3D e l'utilizzo di tecnologie informatiche ad alte prestazioni ed ibride per applicazioni CTF e simulazione del plasma. I membri del gruppo hanno partecipato a numerosi progetti di ricerca internazionali e nazionali e hanno una ricca produzione scientifica su riviste internazionali del settore.
Ingegneria Biomedica: Il gruppo è da tempo coinvolto nelle attività di ricerca presso il Dipartimento sull'interazione dei campi elettromagnetici a bassa frequenza e corpo umano, per la diagnostica e per l'ablazione tumorale, e la stimolazione magnetica transcranica, nell'ambito di una cooperazione con la TU Ilmenau (DE). Più recentemente, in collaborazione con i ricercatori del Laser Team del Dip. Di Ingegneria, e con il Dip. Multidisco. di Specialità Medico – Chirurgiche e Odontoiatriche, è stata avviata una nuova attività, per indagare le possibili soluzioni diagnostiche Bed-Side per le malattie dei denti. Inoltre, l'interazione con i ricercatori nel campo dell'odontoiatria ha favorito l'interesse per l'interazione dei campi magnetici con il processo di osteogenesi.
Problemi inversi e progetto ottimale nell'elettromagnetismo a bassa frequenza. La linea di ricerca comprende molteplici attività nel campo dell'analisi teorica e numerica dei dispositivi elettromagnetici. I risultati più recenti includono l’analisi delle caratteristiche dei vari metodi di regolarizzazione, anche in ambito di machine learning, applicati a un problema di riferimento e l'impostazione di un quadro teorico e numerico per la risoluzione di problemi elettromagnetici a bassa frequenza utilizzando approcci di Machine-Learning, principalmente Deep e/o Physics-Informed Neural Networks nell'ambito di una collaborazione di lunga durata con i colleghi delle Univ. di Pavia, Pisa e Padova.
Previsione di eventi di fulminazione. La linea di ricerca ha come scopo la verifica difattibilità della previsione di eventi di fulminazione attraverso la misura dei campi elettromagnetici associati ai cosiddetti “precursori”. Tali eventi sono caratterizzati da una “firma” elettromagnetica che ci si propone di rivelare mediante l’uso di tecniche data-based, in modo da consentire ai sistemi di protezione di dispositivi sensibili di sconnettere gli apparati in tempo.
Responsabile: Massimo VITELLI
Partecipanti: Andrea Gaetano CHIARIELLO, Luigi COSTANZO, Alessandro FORMISANO, Kifayat ULLAH, Alessandro LO SCHIAVO, Massimo VITELLI, Alessandro SARRACINO, Ehsan AKBARISEKEHRAVANI
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Circuiti e Calcolo Elettromagnetico (CIRCE), Laboratorio Energy Harvesting, Laboratorio di Elettronica
Aerodynamics and Dynamics of Aircaft and Spacecraft - Aerodinamica e Dinamica di Velivoli Atmosferici e Spaziali
Descrizione linee di ricerca:
L’obiettivo generale del Gruppo di Ricerca è quello di contribuire a rendere il trasporto aereo più efficiente e maggiormente diffuso, a ridotto impatto ambientale, più economico e con standard di sicurezza più elevati attraverso l’utilizzo di: tecniche di progettazione aerodinamiche innovative in grado di assicurare configurazioni dalle elevate efficienze aerodinamiche; tecniche di progettazione strutturale all’avanguardia che utilizzano materiali avanzati; sistemi di bordo e sistemi propulsivi migliorati; prestazioni di volo e stabilità incrementate; sistemi UAV avanzati per la raccolta di informazioni geografiche per il completamento di database tematici finalizzati al supporto dei processi di governo del territorio e all'ambiente; simulazione numerica dell’aerodinamica del velivolo con metodi di ultima generazione. Le attività del Gruppo di ricerca sono raccolte in aree di competenza che, pur conservando una spiccata specificità nei propri ambiti disciplinari, interagiscono tra loro per il raggiungimento dell’obiettivo generale:
Area Aerodinamica e Fluidodinamica
Simulazione di flussi sub-trans-supersonici di interesse aeronautico.
- Sviluppo di metodi e modelli per la simulazione numerica di flussi turbolenti interni ed esterni (DNS, LES, RANS).
- Analisi dell’aerodinamica del velivolo mediante simulazioni numeriche basate su tecniche di ultima generazione (e.g., dynamic meshing).
Simulazione di flussi ipersonici.
- Sviluppo di metodi e modelli per la simulazione numerica di flussi iperveloci in condizioni di non-equilibrio termochimico sia per atmosfera terrestre sia extraterrestre.
- Analisi dell’aerodinamica e aerotermodinamica di veicoli di ri-entro mediante simulazioni numeriche sia su griglie di calcolo strutturate sia ibride.
Area Ottimizzazione Multidisciplinare di veicoli di ri-entro.
- Sviluppo di metodi e modelli per l’ottimizzazione multidisciplinare di configurazioni complesse di veicoli di ri-entro sia abitati sia non-abitati da orbita LEO.
- Generazione parametrica procedurale della configurazione aerodinamica di veicoli da rientro mediante metodo SBISO (Skeleton-Based Integral Soft Objects) per la contestuale integrazione con opportune procedure di ottimizzazione in grado di individuare la forma ottima legata a prescritti parametri di merito.
Area Meccanica del volo. Modellistica, simulazione e controllo di velivoli atmosferici e progettazione di velivoli
- Modellistica e controllo di UAV (Unmanned Aerial Vehicle) di tipo QuadRotor.
- Progettazione, modellistica e controllo di velivoli UAV di tipo TiltRotor.
- Rilevazione e isolamento di guasti di sensore e attuatore di velivoli dell’Aviazione Generale. d. Ottimizzazione di traiettorie per UAV.
- Simulazione e ottimizzazione di traiettoria per velivoli regionali a basso impatto ambientale.
- Controllo di volo per velivoli flessibili.
- Controllo di volo per velivoli di rientro in atmosfera terrestre ed extraterrestre.
- Swarming di velivoli unmanned. Guida, navigazione e controllo di sciami di velivoli
Responsabile: Antonio VIVIANI
Partecipanti: Giuseppe PEZZELLA ; Luciano BLASI; Luigi IUSPA; Immacolata NOTARO; Nicolina MONTELLA
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Strutture Aerospaziali; Laboratorio di Dinamica e Controllo del Volo
Aerospace Composite Structures: integrated design, analysis and production - Strutture aerospaziali in materiale composito: progettazione analisi e produzione integrate
Descrizione linee di ricerca: Il Gruppo di Ricerca ha la finalità di rendere efficienti la progettazione, l’analisi e la produzione delle strutture aerospaziali in materiale composito attraverso lo sviluppo di metodologie numeriche e sperimentali finalizzate alla caratterizzazione del comportamento delle strutture in materiale composito in presenza di sollecitazioni multi-fisiche (aero-termo-meccaniche) ed in presenza di danneggiamento. I risultati attesi sono la riduzione dei tempi, dei costi e del rischio associati allo sviluppo di un componente in composito (dimensionamento, fabbricazione ed assemblaggio). L’obiettivo formulato presuppone implicitamente una forte connotazione interdisciplinare del Gruppo di Ricerca che comprende al suo interno competenze su strutture aerospaziali, tecnologie, materiali, aerodinamica, e statistica. Le attività che il Gruppo di Ricerca effettua presuppongono spesso l’intersezione di questi specifici ambiti disciplinari finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo.
Linee di ricerca:
Sviluppo di metodologie numeriche specifiche per la gestione del danneggiamento di strutture aerospaziali in materiale composito:
- Sviluppo di metodologie numeriche multidisciplinari (strutture-materiali- aerotermodinamica) per la progettazione di strutture tolleranti al danno.
- Sviluppo di metodologie di analisi di tipo multiscala per compositi avanzati.
- Sviluppo di metodologie di analisi per la simulazione dell'innesco e della progressione del danno nei compositi.
- Sviluppo di metodologie per la simulazione dei fenomeni di impatto sui compositi.
- Applicazione di approcci probabilistici per la determinazione delle proprietà di resistenza e tolleranza al danno di strutture in materiale composito.
Sviluppo di modelli analitico-numerici per i materiali compositi in presenza di sollecitazioni aero-termo-strutturali.
Sviluppo di modelli analitico-numerici per la caratterizzazione dei materiali compositi e la produzione di strutture in materiale composito di interesse aerospaziale
- Sviluppo di metodi per la simulazione dei processi produttivi delle strutture in composito
- Sviluppi di modelli RVE per materiali compositi rinforzati tolleranti al danno.
- Sviluppo di modelli cinetici e termo-strutturali per la simulazione del comportamento dei materiali compositi soggetti a condizioni di fiamma.
Utilizzo / sviluppo di tecniche sperimentali utili a validare gli strumenti numerici e a monitorare lo stato di salute delle strutture in materiale composito:
- Utilizzo di tecniche innovative non distruttive e di sensori embedded per la determinazione dello stato tensionale del componente strutturale.
- Utilizzo di tecniche innovative non distruttive di Emissione Acustica.
- Utilizzo di test meccanici per lo studio dell’impatto su compositi tradizionali e innovativi.
- Utilizzo di test meccanici per la caratterizzazione di compositi per applicazioni strutturali aerospaziali realizzati con polimeri riciclati, fibre naturali e fibre di basalto.
Sviluppo di procedure e tecniche efficienti di riparazione di strutture in materiale composito danneggiate:
- Individuazione dei criteri e Sviluppo di strumenti efficienti per il design delle riparazioni di strutture in materiale composito.
Sviluppo di procedure e tecniche efficienti per la progettazione e la produzione mediante processi di Additive Manufacturing:
- Individuazione dei criteri e Sviluppo di strumenti efficienti per il design for additive di strutture aerospaziali light-weight.
Responsabile: Aniello RICCIO
Partecipanti: Antonio GAROFANO (dottorando); Miriam BATTAGLIA (dottorando); Concetta PALUMBO (dottorando); Ferdinando BALDIERI (dottorando); Valerio ACANFORA (assegnista); Angela RUSSO; Andrea SELLITTO; Luigi IUSPA; Antonio VIVIANI; Aniello RICCIO; Immacolata NOTARO (assegnista); Mauro ZARRELLI (CNR).
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Strutture Aerospaziali; Laboratorio di Stampa 3D
Biomedical Engineering - Ingegneria Biomedica
Descrizione linee di ricerca:
Sensoristica fotonica per la biomedica: la tematica prevede la progettazione e lo sviluppo di dispositivi fotonici, basati su nanostrutture plasmoniche, capaci di monitorare l’interazione di un recettore (biologico o biomimetico) con la molecola target, anche a bassissime concertazioni (fino alla misura della singola molecola). Nello specifico, i biosensori fotonici sono sviluppati sia su guide d’onda planari che in fibra ottica. I biochip fotonici realizzati possono essere utilizzati per realizzare Point of Care Test (POCT), utilizzando semplici setup sperimentali, di piccole dimensioni e con la capacita di monitorare sia differenti molecole/marcatori che ampi intervalli di concentrazioni (da concentrazioni femto-molari fino a concentrazioni micro-molari).
Sviluppo di bio-recettori per la biomedicina: la tematica prevede lo sviluppo di specifici biorecettori per la realizzazione di sensori selettivi per ambiti applicativi in campo biomedico. Esempi sono sensori per la nano-detezione di DNA tumorale circolante, di targets di regolazione di morte cellulare, targets metabolici e per free nucleosomi etc. Particolare enfasi sarà anche dedicata alla detezione di DNA tumorale circolante metilato ed alla messa a punto di nanotecnologie per la detezione di modifiche epigenomiche rilevanti per le patologie umane.
Diagnostica per immagini: la tematica si pone nell’ambito dello sviluppo di strategia di “medicina personalizzata” e prevede lo sviluppo di molecole radioattive e/o fluorescenti, che possano essere impiegate in tecniche diagnostiche, quali ad esempio SPECT e PET, per l’acquisizione e elaborazione intelligente di immagini di diverse patologie a base soprattutto infiammatoria, incluse ma non limitate a differenti tipi di tumori solidi e/o liquidi. Nello specifico, i bersagli cellulari sono selezionati tra le proteine e/o recettori cellulari che sono iperespressi solo nei tessuti coinvolti dalla patologia. Quando i ligandi sono già stati identificati, essi vengono convertiti in traccianti diagnostici partendo da avanzati calcoli computazionali, che aiutando ad identificare le regioni degli stessi che possono essere modificate per l’inserzione delle porzioni radiomarcate o fluorescenti, senza produrre effetti significativi sull’affinità e sulla selettività dei ligandi stessi. Questo tipo di approccio permette non solo di avere immagini più chiare e selettive dei tessuti malati (effetto diagnostico), ma produce anche informazioni fenotipiche addizionali che possono essere utilizzate per il corretto intervento terapeutico (effetto prognostico). Nel caso in cui è noto il target molecolare ma non sono ancora disponibili i ligandi da cui far partire lo studio, calcoli preliminari di chimica computazione vengono realizzati per identificare gli “hit compounds”, che sono sottoposti a diversi cicli di ottimizzazione sintetica fino all’ottenimento del “lead compound”. Quest’ultimo viene poi opportunamente modificato per essere convertito in un tracciante diagnostico.
Sistemi di elaborazione per l’analisi delle immagini e dei segnali cerebrali: la tematica prevede attività nel campo della acquisizione ed elaborazione intelligente di immagini e segnali cerebrali. Tali attività sono mirate a progettare e validare nell’ambito di trial clinici, nuovi protocolli di acquisizione e pipeline migliorative di elaborazione numerica per l’estrazione di marker quantitativi da immagini e segnali cerebrali per migliorare il supporto all'interpretazione clinica dei meccanismi di invecchiamento cerebrale e delle malattie neurologiche e psichiatriche. Partendo dalle tecniche e dalle apparecchiature di Risonanza Magnetica avanzata ed un corredo di apparati ausiliari per l’acquisizione di segnali biomedici, è altresì previsto lo studio e lo sviluppo di modelli computazionali per la simulazione della fisiologia e del comportamento umano, favorendo l’impiego di metodi di intelligenza artificiale a supporto della ricerca biomedica, e mirando alla realizzazione ed al perfezionamento strumenti in-silico di medicina predittiva e personalizzata, per integrare la diagnostica e prognostica di patologie neurologiche e per monitorare gli effetti di farmici e riabilitazione.
Elettromagnetismo numerico per applicazioni biomediche: il gruppo da tempo è attivo nella ricerca sull'interazione dei campi elettromagnetici a bassa frequenza con il corpo umano, per applicazioni di diagnostica, di ablazione tumorale, e di stimolazione magnetica transcranica. Le competenze presenti nel team hanno consentiti di sviluppare efficaci modelli numerici per il calcolo del campo elettromagnetico nei casi citati (problema diretto). La tematica comprende inoltre l'analisi teorica e numerica delle relazioni tra misure di campo intorno al corpo umano e sorgenti biologiche (problemi inversi). I risultati più recenti includono l’analisi delle caratteristiche dei vari metodi di regolarizzazione, anche in ambito di machine learning.
Sviluppo di POCT per specifiche applicazioni: la tematica prevede lo sviluppo, l’implementazione e validazione di dispositivi per Point of Care Test nei seguenti ambiti applicativi:
- Identificazione in maniera precoce ed efficiente diversi processi patologici, inclusi quelli virali e tumorali. Nello specifico, in campo antitumorale, diverse biomolecole iperespresse e/o rilasciate dal sito neoplastico (proteine circolanti, recettori di membrana, esosomi, acidi nucleici) sono investigate come potenziali “hallmarks” da rilevare mediante l’applicazione di biochip fotonici opportunamente funzionalizzati con ligandi che interagiscono con i suddetti bersagli in maniera efficiente e selettiva. Quando i ligandi da utilizzare sono già stati identificati, avanzati calcoli computazionali vengono applicati per identificare le regioni degli stessi che possono essere modificate per l’inserzione dei gruppi funzionali utili per legarli alla superficie del biochip (tioli, ammine, etc), senza produrre effetti significativi sull’affinità e sulla selettività dei ligandi stessi. Nel caso in cui è noto il target molecolare ma non sono ancora disponibili i ligandi da cui far partire lo studio, calcoli preliminari di chimica computazione vengono realizzati per identificare gli “hit compounds”, che sono sottoposti a diversi cicli di ottimizzazione sintetica fino all’ottenimento del “lead compound”. Quest’ultimo viene poi opportunamente modificato per essere covalentemente legato alla superficie del biochip fotonico.
- Determinazione qualitativa e quantitativa di biomarcatori dell’infiammazione e del danno tissutale presenti in saliva e fluido crevicolare gengivale, ed in generale nei fluidi biologici, per la diagnosi precoce ed il monitoraggio di patologie del cavo orale, in particolare della parodontite, e di patologie sistemiche.
Diagnostica a microonde: questo tema di ricerca concerne sistemi di imaging biomedicali basati sull’uso di onde elettromagnetiche alle frequenze delle microonde. Il fine è quello di sviluppare un ulteriore strumento diagnostico complementare alle tecnologie correntemente usate nell’ambito della diagnostica medica, e al contempo che sia compatto, altamente portabile, veloce e che consenti di ripetere l’esame senza limitazioni. L’attività di ricerca spazia dalla modellazione dell’interazione tra i campi elettromagnetici e i tessuti, alla progettazione dei sensori e della circuiteria a microonde, dagli algoritmi per il processing e condizionamento del segnale al fine di ottenere le immagini, a metodi non invasivi per la predizione del SAR e alla realizzazione di phantom antropomorfi degli organi che emulino le caratteristiche elettromagnetiche. Le principali applicazioni riguardano:
- La diagnostica precoce del tumore al seno
- La rilevazione e classificazione di ictus
- La rilevazione fratture del cranio e ematomi subdurali
- Diagnostica di fratture di arti e monitoraggio osteoporosi.
- Rivelazioni segni vitali di soggetti sepolti e non direttamente accessibili.
Sensori a microonde: la tematica prevede la progettazione e lo sviluppo di dispositivi a microonde basati sulla tecnologia delle microstrisce, e più in generale sulla SIW, atti alla caratterizzazione delle proprietà di dielettriche e conduttive di materiali solidi e liquidi. Più in dettaglio, i dispositivi possono essere risuonatori, metastrutture, interferometri, etc. la cui risposta varia quando sono posti a contatto con il mezzo target. Da tale variazione, mediante opportuni algoritmi, le proprietà dei tessuti, e in particolare, la concentrazione delle sostanze da cui esse dipendono, vengono determinate. Particolare enfasi è posta sullo sviluppo di algoritmi super-risolventi che mitigano i bassi valori del fattore di qualità tipico. Le principali applicazioni riguardano:
- Monitoraggio continuo del glucosio nel sangue
- Determinazione di inquinanti in acqua
- Rilevazione di sostanze tossiche in alimenti.
Analisi varianti virali nell’outcome clinico: la tematica prevede lo studio della relazione tra varianti virali, caratteristiche biomolecolari dell’ospite, stato vaccinale e progressione della malattia.
Responsabile: Luigi ZENI
Partecipanti: Aldo MINARDO; Nunzio CENNAMO; Giovanni LEONE; Alessandro FORMISANO; Raffaele SOLIMENE; Lucia ALTUCCI; Italo ANGELILLO; Nicola COPPOLA; Mariantonietta PISATURO; Salvatore CAPPABIANCA; Alfonso REGINELLI; Fabrizio ESPOSITO; Leandro DONISI; Luigi GUIDA; Marco ANNUNZIATA; Adriana BORRIELLO; Fulvio DELLA RAGIONE; Debora BENCIVENGA; Emanuela STAMPONE; Vincenzo CARAFA; Rosaria BENEDETTI; Ugo CHIANESE; Chiara PAPULINO; Sandro COSCONATI; Salvatore DI MARO; Francesco ARCADIO; Angelantonio PICCIRILLO; Gennaro CECORO; Fiore CAPASSO; Domenico DEL PRETE; Stefano SPINA; Rosalba PITRUZZELLA; Riccardo ROVIDA.
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Microscopia Elettronica
Computer Science – Informatica
Descrizione linee di ricerca:
Cloud Computing, Edge Computing, Cloud Continuum: L'attività di ricerca si concentra sullo sviluppo di nuovi modelli, algoritmi e infrastrutture per ottimizzare l'efficienza, la sicurezza e l'affidabilità delle risorse cloud distribuite e federate. Aspetti fondamentali che sono affrontati riguardano: Ottimizzazione delle risorse cloud: elaborazione di algoritmi e strategie intelligenti per la gestione efficiente delle risorse cloud. Ciò potrebbe includere la pianificazione dinamica delle risorse, il bilanciamento del carico di lavoro, l'allocazione delle risorse in base alle richieste dei servizi e l'ottimizzazione dei tempi di risposta. Architetture e protocolli per il cloud continuum: Il cloud continuum è un'evoluzione del concetto di cloud computing che incorpora diverse tipologie di risorse, come cloud pubblico, privato, ibrido e edge computing. La ricerca si concentra sullo sviluppo di nuove architetture e pattern architetturali, di design, esecuzione e deployment per abilitare una gestione efficiente e scalabile del cloud continuum, consentendo alle applicazioni di trarre vantaggio da un'ampia gamma di risorse disponibili. Automazione e intelligenza artificiale nel cloud continuum: Un'altra area di ricerca riguarda l'applicazione di tecniche di automazione e intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione delle risorse nel cloud continuum. Ciò coinvolge l'utilizzo di algoritmi di apprendimento automatico per l'analisi dei dati, la predizione della domanda di risorse, l'ottimizzazione del consumo energetico e l'automazione dei processi di provisioning delle risorse. Gli ambiti applicativi sono molteplici, tra cui: Sanità e assistenza sanitaria: La gestione sicura e scalabile dei dati medici sensibili, l'elaborazione distribuita delle immagini mediche, la condivisione delle informazioni tra ospedali e centri di ricerca, l'analisi di grandi dataset medici per la ricerca e la diagnosi assistita da intelligenza artificiale. Industria manifatturiera e automazione: L'utilizzo di risorse cloud distribuite per la raccolta e l'analisi dei dati di produzione in tempo reale, la gestione delle operazioni di supply chain, la pianificazione della produzione e la manutenzione predittiva degli impianti. Smart city e Internet delle cose (IoT): L'integrazione di sensori e dispositivi IoT in una piattaforma cloud per raccogliere, elaborare e analizzare dati provenienti da diverse fonti, consentendo la gestione intelligente delle risorse energetiche, la pianificazione dei trasporti, il monitoraggio ambientale e la sicurezza pubblica.
Automated Software Analysis and Reenginering for Modernization, Decomposition, Deployment, and Orchestration on Cloud, Cloud-Edge, Big Data, and Quantum Technologies: Le attività svolte in questa linea di ricerca nascono dall’esperienza maturata nel campo delle compilatori e trasformazioni di codice basate su pattern. A partire da software esistente (software legacy), la linea di ricerca ha come obiettivo la modernizzazione del codice esistente attraverso il riconoscimento di pattern algoritmici, pattern di design e pattern architetturali. Altro obiettivo è la decomposizione del software, con l’applicazione delle best practies delle Architetture Orientate ai Servizi e della decomposizione a Microservizi. La linea di ricerca prevede, anche, la possibilità di distribuire in modo automatico il software decomposto attraverso l’utilizzo di tecniche di Infrastrutture come codice e la modellazione attraverso formati standard dell’architettura hardware e software del software oggetto dell’analisi. Infine, la linea di ricerca, investiga anche nella possibilità di orchestrare in maniera efficiente e distribuita le componenti del software. Il tutto in maniera del tutto agnostica rispetto alle tecnologie di riferimento, infatti, la linea di ricerca prevede la decomposizione e distribuzione anche su tecnologie miste dove un componente può essere distribuita in cloud mentre un altro viene eseguito su piattaforme big data.
Semantic and Pattern based Artificial Intelligence Techniques for Automated Discovery, Composition, and Orchestration of Cloud Services in Multiple, Interoperable, and Federated Clouds: La linea di ricerca si concentra sull'avanzamento della gestione dei servizi cloud utilizzando l'intelligenza artificiale semantica e i modelli. L'obiettivo è migliorare la comprensione e l'interoperabilità dei servizi cloud attraverso l'uso di tecniche semantiche come il ragionamento semantico e le ontologie. Questo porta a una scoperta, composizione e orchestrazione più accurate ed efficienti dei servizi. Vengono applicate anche tecniche di intelligenza artificiale basate su modelli per identificare i modelli nei servizi cloud utilizzando algoritmi di machine learning, data mining e riconoscimento dei modelli. Questa conoscenza viene utilizzata per automatizzare i processi di rilevamento, composizione e orchestrazione dei servizi, ottimizzando la selezione e l'utilizzo dei servizi cloud. La ricerca si concentra anche sull'automazione della scoperta dei servizi cloud pertinenti e sulla composizione automatica di più servizi per creare applicazioni complesse. Inoltre, vengono sviluppati meccanismi di orchestrazione intelligenti per adattarsi alle condizioni operative, ottimizzare l'allocazione delle risorse e garantire un'esecuzione affidabile ed efficiente dei servizi cloud. L'obiettivo è migliorare l'efficienza e l'agilità delle applicazioni basate su cloud. La ricerca si estende anche agli ambienti cloud multipli, interoperabili e federati, affrontando sfide come l'interoperabilità e l'integrazione tra diverse infrastrutture cloud e sfruttando la federazione dei cloud per la condivisione delle risorse e la collaborazione tra ambienti cloud.
Semantic and Pattern-based Artificial Intelligence Techniques for Software Engineering: Il nostro gruppo di ricerca si dedica all'ingegneria del software utilizzando tecniche di intelligenza artificiale semantica e basata su pattern per migliorare il ciclo di vita dello sviluppo del software. La nostra ricerca si concentra sulla scoperta automatica di design pattern nei sistemi software esistenti, analizzando repository di codice, architetture e artefatti software per identificare pattern ricorrenti. Questo processo automatizzato aiuta gli ingegneri del software a prendere decisioni di progettazione informate, migliorando la qualità e la manutenibilità del software. Inoltre, automatizziamo l'estrazione dei requisiti da diverse fonti, come documenti in linguaggio naturale e feedback degli utenti, per allineare le aspettative delle parti interessate con il prodotto finale. Utilizziamo anche tecniche semantiche e algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la comprensione di artefatti software come codice sorgente, documentazione e pattern, facilitando la comprensione del codice, il rilevamento dei bug e l'analisi dell'impatto. Inoltre, promuoviamo l'ingegneria del software basata su pattern, utilizzando pattern consolidati per migliorare la progettazione e l'implementazione del software. Sviluppiamo tecniche che incorporano la conoscenza dei pattern nei processi di ingegneria del software, aiutando gli ingegneri a identificare pattern adatti a sfide specifiche. Infine, ci concentriamo sulla gestione della conoscenza nell'ingegneria del software, organizzando e strutturando archivi di conoscenza per facilitare il recupero di informazioni rilevanti e la condivisione delle conoscenze tra i team di ingegneri. Il nostro obiettivo è migliorare le pratiche di sviluppo del software e promuovere il riutilizzo della conoscenza nel campo dell'ingegneria del software.
Machine / Deep Learning for Automated Software Assets Generation and Management (Requirements, Code, Testing, and Infrastructure): La linea di ricerca si occupa di investigare algoritmi di intelligenza artificiale (AI) noti come Large Language Models (LLM), che impiegano metodi di deep learning e set di dati straordinariamente grandi per comprendere, condensare, produrre e anticipare nuovo testo. La frase "IA generativa" è anche strettamente correlata agli LLMs, che in realtà sono un sottoinsieme dell'IA generativa progettato esclusivamente per supportare la creazione di contenuti basati su testo. Tutti i tipi di comunicazione umana e tecnica si basano sul linguaggio, che fornisce le parole, la semantica e la grammatica necessarie per trasmettere idee e concetti. Un modello linguistico ha una funzione simile nel campo dell'intelligenza artificiale, fungendo da base per la comunicazione e la creazione di nuove idee. L’obiettivo della linea e’ utilizzare questi algoritmi per supportare tutto il ciclo di vita dello sviluppo software, dalla stesura dei requisiti, alla generazione di codice a partire dal requisito stesso scritto in linguaggio naturale, dalla generazione dei test case e piani di collaudo in linguaggio naturale alla generazione dell’infrastruttura dai requisiti o dal codice.
Machine / Deep Learning for Text Anonymization and Privacy-Preserving: La linea di ricerca esplora tecniche e metodologie di natural language processing per l’analisi e l’individuazione di entità all’interno di testi scritti in linguaggio naturale con lo scopo di anonimizzare e/o pseudoanonimizzare gli stessi e garantire diversi livelli di privacy. Vengono utilizzati sia approcci supervisionati che non supervisionati per addrestrare reti neurali specializzate in riconoscimento ed estrazione di entità. La linea di rticerca investiga anche modelli di apprenndimento profondo e la possibilita di definire una metodologia che unisca il generalismo di una rete neurale con la precisione di unsistema esperto che abbia alla base un grafo di conoscenza ben definito del dominio applicativo.
Federated and Machine / Deep Learning for eHealth: Il nostro gruppo di ricerca si dedica all'eHealth, utilizzando tecniche di apprendimento federato nel contesto del diabete e della sclerosi multipla (SM). L'apprendimento federato consente la formazione collaborativa di modelli di machine learning su fonti dati decentralizzate, preservando la privacy e la sicurezza dei dati sanitari. Miriamo a migliorare l'accuratezza dei modelli predittivi e delle raccomandazioni terapeutiche sfruttando la conoscenza collettiva nei dati distribuiti. Utilizzando algoritmi di Machine e Deep Learning, analizziamo dati sanitari su larga scala per sviluppare modelli avanzati. La nostra ricerca si concentra sulla diagnosi precoce, il trattamento personalizzato e il monitoraggio della progressione del diabete e della SM. Utilizziamo tecniche come reti neurali convoluzionali e reti neurali ricorrenti per migliorare la diagnostica e gli esiti per i pazienti. La privacy e la sicurezza dei dati sono fondamentali per le nostre attività di ricerca. Adottiamo tecniche di tutela della privacy come l'apprendimento federato e la privacy differenziale per salvaguardare le informazioni sui pazienti. Nel campo del Diabetes Management, sviluppiamo sistemi intelligenti per la gestione del diabete. Utilizzando algoritmi di machine learning e deep learning su dati come i livelli di glucosio, registrazioni del dosaggio di insulina e fattori dello stile di vita, creiamo modelli personalizzati per la previsione della glicemia, l'aggiustamento della dose di insulina e le raccomandazioni sullo stile di vita. Il nostro obiettivo è ottimizzare la gestione del diabete e migliorare i risultati sanitari.Nell'analisi della sclerosi multipla (SM), sfruttiamo tecniche di apprendimento automatico per la progressione della malattia, la risposta al trattamento e la previsione delle ricadute, utilizzando fonti dati come cartelle cliniche, imaging cerebrale e risultati dei pazienti. La nostra ricerca contribuisce all'eHealth, garantendo privacy e sicurezza dei dati e sviluppando modelli avanzati per migliorare la gestione del diabete e della SM.
Supporto all’Industria 4.0 mediante tecniche di Machine, Deep e Federated Learning e Process Mining: Nell'ambito dell'Industria 4.0 rapidità, efficacia ed efficienza dei processi di sviluppo rappresentano il perno intorno al quale si stanno sviluppando le moderne tecnologie. In questo ambito, il gruppo di ricerca studia algoritmi e tecniche di machine, deep learning e federated learning per l'analisi e il riconoscimento di immagini per il supporto all'Industria 4.0, in particolare per il riconoscimento dei bordi (edge recognition) e delle texture (texture recognition) nelle immagini industriali, oltre che di specifici soggetti presenti in queste immagini. Questi algoritmi possono essere utilizzati per analizzare le immagini catturate durante lo svolgimento dei processi propri dell'Industria 4.0, consentendo la rilevazione automatica di difetti, anomalie o pattern rilevanti per il controllo qualità, la manutenzione predittiva o l'ottimizzazione dei processi produttivi. Inoltre, nei contesti automatizzati e semi automatizzati, possono fornire un utile supporto per il rilevamento di ostacoli e la definizione di percorsi sicuri all'interno di aree di lavoro in cui avviene l'interazione uomo-macchina. L'obiettivo è quello di creare modelli di machine learning, deep learning e federated in grado di apprendere e distinguere i bordi e le texture specifiche dei prodotti o dei componenti industriali, consentendo una rapida e accurata identificazione di problemi o caratteristiche significative nelle immagini, al fine di migliorare l'efficienza, la qualità e l'affidabilità dei processi.
Automated Optimization and Validation of eGovernment Business Processes with Semantics and Knowledge based Artificial Intelligence: La linea di ricerca sull' Ottimizzazione e Validazione Automatizzata di Processi di Business si propone di applicare una metodologia basata sulla semantica e un sistema di supporto decisionale che supporti l'analisi dei processi, gli ingegneri dei processi, gli esperti di legge e gli esperti di sicurezza al fine di facilitare l'ottimizzazione e la validazione dei processi aziendali. Il gruppo di ricerca ha realizzato un sistema che si basa sulla definizione di una rappresentazione semantica dei processi di e-government attraverso BPMN (Business Process Model Notation) che sono semanticamente annotati con i concetti e le relazioni delle ontologie di dominio, al fine di rappresentare automaticamente i processi di e-governement e le esigenze di conformità legale, e di eseguire inferenze automatizzate su tali rappresentazioni. Gli obiettivi di tale linea di ricerca sono (a) ottimizzare i processi, rispettando vincoli legati alla legge, alla sicurezza e alle risorse, e (b) validare la correttezza dei processi rispetto al comportamento atteso dei processi, alle valutazioni dei rischi per la sicurezza e alla conformità legale. Tale linea di ricerca affronta sfide legate a: (i) i limiti dello stato dell'arte delle valutazioni dei processi aziendali; (ii) l'applicazione di BPMN al contesto del e-government e (iii) la conformità legale dei processi proposti supportando, i seguenti compiti e sfide: a) Compatibilità dei ruoli; (b) Correttezza del processo; c) Ri-ingegnerizzazione e ottimizzazione del processo;(d) Riutilizzo del processo e (e) Miglioramento del processo (per implementare o sostituire una o più delle attività automatiche definite mediante servizi online (cloud).
Automated Storytelling in Cultural Heritage: L'automated storytelling è una ricerca in crescita che nel contesto del Patrimonio Culturale può essere utilizzato per presentare informazioni storiche e culturali in modo coinvolgente. Questa linea di ricerca esplora l'applicazione della semantica nel contesto dell'automated storytelling nel patrimonio culturale, concentrandosi sulla creazione di una rappresentazione completa delle narrazioni/storie, evidenziando le loro strutture, elementi principali, relazioni e collegamenti a materiali multimediali. Gli obiettivi di ricerca includono l'utilizzo delle tecnologie semantiche nell'automated storytelling per rendere le narrazioni più organizzate e accessibili agli utenti, la proposta di un framework per la creazione di una rappresentazione grafica delle narrazioni mettendone in evidenza gli elementi principali e le relazioni, l'indagine su come le tecnologie semantiche e i linguaggi visuali possono facilitare la costruzione automatica di storie per gli utenti, come storici, letterati, archeologi o sceneggiatori e la proposta di un motore inferenziale per migliorare la comprensione e l'esperienza dell'utente. Le attività di ricerca includono l'analisi delle tecnologie semantiche esistenti e del loro utilizzo nella rappresentazione di narrazioni automatizzate, lo studio delle caratteristiche delle narrazioni e dei materiali multimediali associati, la ricerca e/o progettazione di un framework per la rappresentazione e fruizione delle narrazioni utilizzando le tecnologie semantiche, e l'implementazione di un motore inferenziale per migliorare la comprensione e l'immersione dell'utente nel contesto storico o culturale.
Process Mining: La linea di ricerca analizza l'uso del process mining per migliorare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dei procedimenti giuridici. Si concentra su come queste tecniche possano ottimizzare i processi legali, considerando l'importanza di un sistema legale equo e rapido. Gli obiettivi di ricerca includono l'esplorazione dell'applicazione del process mining nei procedimenti giuridici per migliorare l'efficienza e ridurre i tempi di gestione dei casi, l'analisi dell'efficacia del process mining nel contesto legale, l'esame del suo contributo alla trasparenza dei procedimenti giuridici e la valutazione dell'impatto tecnologico sull'efficacia e qualità delle decisioni giuridiche. La ricerca si basa su una revisione della letteratura accademica e sui casi di studio esistenti, e utilizza strumenti di analisi qualitativa e quantitativa. I risultati attesi includono l'identificazione delle criticità attuali dei processi legali e dei benefici derivanti dal process mining, oltre alle linee guida per l'implementazione efficace di questa tecnologia. La ricerca mira a migliorare l'accesso alla giustizia e la fiducia nel sistema legale.
Artificial Intelligence, BlockChain and Smart Contracts for BIM - Buiding Information Modeling: La digitalizzazione del settore edilizio e delle infrastrutture è stata promossa dal D.Lgs. n. 36/2023, che ha introdotto numerose disposizioni sull'utilizzo del BIM e sulla digitalizzazione dei contratti pubblici. L'obiettivo della linea di ricerca è quello di creare un sistema di e-procurement interoperabile con i sistemi gestionali della pubblica amministrazione e degli altri soggetti coinvolti. Questo sistema potrebbe avvalersi dell'intelligenza artificiale e della blockchain per analizzare e verificare i dati, secondo le linee guida del PNRR nella riforma "RecoveryProcurement Platform". La prospettiva ambiziosa della digitalizzazione degli appalti pubblici suggerisce di integrare l'approccio BIM con un sistema basato sull'intelligenza artificiale e sulla blockchain, in modo da automatizzare il ciclo di vita dei contratti, ridurre i tempi di esecuzione e limitare le controversie. Questo tema, già presente nel settore finanziario, sarà oggetto di ricerca nel contesto degli appalti pubblici, considerando l'importanza del principio del risultato secondo il D.Lgs. n. 36/2023. Un altro obiettivo di questa linea di ricerca riguarda la verifica digitale automatizzata delle norme UNI11337 (digitalizzazione del settore delle costruzioni), utilizzando tecnologie semantiche e di intelligenza artificiale per verificare la conformità degli artefatti di progettazione agli standard e la completezza di un processo amministrativo nel settore delle costruzioni rappresentato in BPMN.
Simulation, Evaluation and Forecasting of Complex Systems: L’attività di ricerca è incentrata sull’analisi delle prestazioni di infrastrutture di calcolo e sull’applicazione di tecniche simulative per lo studio di sistemi complessi, ove modelli formali o analitici non sono utilizzabili. Contributi scientifici includono lo sviluppo di simulatori e il loro utilizzo per la valutazione di indici prestazionali nei casi in cui il sistema reale non è disponibile o non ancora sviluppato, per la valutazione e la predizione delle performance di algoritmi di ottimizzazione o software prototipali, per il dimensionamento di infrastrutture di calcolo e di rete. Domini applicativi sono il Calcolo ad Alte Prestazioni; l’analisi dei protocolli di rete e delle architetture distribuite; la simulazione di carichi computazionali o di sistemi IoT in ambito V2X, Smart Energy, Smart Cities.
Mobile Computing and Multi-Agents Systems: L’attività di ricerca affronta lo studio dei paradigmi di calcolo che utilizzano modelli e tecnologie ad agenti. Gli ambiti della ricerca includono la simulazione e lo sviluppo di sistemi autonomi e riconfigurabili, l’utilizzo di tecniche e tecnologie di migrazione del codice per l’offloading della computazione, la progettazione di algoritmi di swarm e di collective intelligence. Tra i domini applicativi si citano le Digital Humanities, le Smart Cities, I sistemi V2X, la Smart Energy, le Smart Water Network, il calcolo distribuito, l’IoT.
Distributed intelligent agents for collaborating smart solar powered microgrids: L'attività di ricerca è incentrata sullo studio e sviluppo di modelli e tecniche per la realizzazione di soluzioni ICT innovative per la gestione collaborativa dei consumi e della produzione decentralizzate di energia. Al fine di ottimizzare l’utilizzo e l’immagazzinamento dell'energia in micro-grids, tecniche di simulazione e modelli ad agenti per il calcolo distribuito. Esempi di applicazioni sono il monitoring distribuito di sistemi IoT, per la misura del consumo di potenza livello delle singole appliances, la valutazione delle abitudini degli utenti riguardo al consumo di energia, la misura e la predizione della produzione di energia dai pannelli solari, ed altri fattori ambientali (e.g. le previsioni del tempo locali), la ricarica intelligente di veicoli elettrici.
Event based simulation and artificial intelligence techniques to support support Sustainable and Smart Urban Mobility: In tale ambito l’attività di ricerca studia nuove soluzioni per la mobilità sostenibile avanzando e integrando le tecnologie allo stato dell’arte per favorire la transizione verso la mobilità elettrica. Tecniche e tecnologie di simulazione ad agenti sono utilizzate per la sperimentazione e la valutazione di strategie ottime per la gestione intelligente dei carichi e della produzione distribuita di energia da fonti rinnovabili. Strumenti di big-data analysis sono di supporto alla raccolta e all’elaborazione dei sistemi di monitoraggio sviluppati in casi pilota (es. Oslo, Brema e Barcellona). Soluzioni innovative basate sull’utilizzo integrato di tecnologie V2X, open data, architetture edge-cloud e modelli di ottimizzazione basati su tecniche di intelligenza artificiale, vengono investigate al fine di massimizzare lo sfruttamento delle infrastrutture stradali mediante la realizzazione di nuovi sistemi di mobilità.
Context Aware Conversational Agents and for Augmented Reality in Cyber-physical systems in Cultural Heritage domain: L’attività di ricerca mira ad accrescere la conoscenza dei siti archeologici e storico-artistici e a sviluppare nuove tecniche di comunicazione per i Beni Culturali, proponendo itinerari tematici attraverso la storia, la cultura e l'arte che coinvolgano il territorio nella sua interezza per la costruzione di una rete integrata di promozione turistica che attualmente manca. Le soluzioni proposte si basano sullo sviluppo di agenti intelligenti che, sfruttando ed estendendo gli standard di interoperabilità per le biblioteche digitali, sono in grado di costruire percorsi culturali ibridi, attraversando punti di interessi fisici e virtuali. L’integrazione di tecniche e tecnologie di natural language processing, le tecnologie IoT e le informazioni di fruizione da parte dell’utente vengono utilizzate per personalizzare la scelta dei contenuti e le modalità di presentazione, anche in realtà aumentata e virtuale , aumentando l’esperienza di fruizione in un sistema cyber-fisico dove interagiscono agenti software e visitatori.
Cybersecurity: Security Evaluation, Assessment, Testing and Automation: La sicurezza non è un prodotto, ma un processo”, la frase , proposta da Bruce Schneier, è un mantra comune e ben mette alla luce il fatto che il problema della sicurezza informatica non si riduce ad un problema tecnico, ma è estremamente trasversale.La linea di ricerca dedicata ai temi della cybersecurity affronta questo tema, estremamente vasto, con un principale obiettivo di riferimento: l’automazione di OGNI attività coinvolta nel mondo della cybersecurity. Questo implica automatizzare processi come quelli del Threat modeling e della risk analysis, automatizzare l’analisi statica e dinamica del codice, automatizzare il ciclo di vita del software, integrando le best practice di cybersecurity, nel contesto della "continous practice” e dei modeli DevOps, automatizzare il security testing and in particolare il penetration testing. La linea si fonda su tre concetti base: Model–based: tutti i processi di automazione sono basati e guidati da una modellazione del Sistema da valutare, (modellazione che può a sua volta essere parzialmente automatizzata) Threat-based: il cuore dell’analisi e dell’automazione è l’identificazione delle minacce di alto livello, ed ogni attività è guidata a identificare, mitigare, impedire o implementare (penetration e security testin) una minaccia. Catalogue-based: tutte le attività si basano su raccolte di dati, organizzate in modo strutturato, che raccolgono e permettono di gestire tutte le informazioni sulla sicurezza recuperabili attraverso ricerche sistematiche, knowledge base aperte o proprietarie. Le tecniche di automazione vengono poi sperimentate in una ampia gamma di sistemi e ambiti applicativi: Sistemi Cloud e HPC, sistemi IoT, Sistemi di rete come il 5G, Infrastrutture per l’Automotive e sistemi automobilistici, Droni e loro sistemi di controllo, sistemi per la pubblica amministrazione.
Large 3D Magneto-Quasi-Static Simulation Using Parallel Computing: In questa attività di ricerca, è stata sviluppata una strategia ottimale per risolvere problemi magneto-quasi-statici (MQS) in 3D in un ambiente parallelo. Sono impiegate i classici approcci basati su MPI e OpenMP, oltre al GPU computing su cluster ad alta prestazioni (cluster Cineca). Il problema numerico che stiamo studiando deriva da una formulazione integrale in forma debole di un problema MQS, che viene infine trasformato in un sistema lineare. Questo sistema lineare deve essere risolto utilizzando un metodo diretto o iterativo. Il nostro obiettivo è ottimizzare le risorse necessarie per l'assemblaggio della matrice, sfruttando i vantaggi di un approccio ibrido e risolvendo efficientemente il sistema lineare. In particolare, il carico computazionale viene distribuito in parallelo su cluster di nodi. Impieghiamo un paradigma OpenMP a livello di nodo e un paradigma MPI a livello di processo tra i nodi. Le simulazioni dei reattori di fusione termonucleare comportano enormi costi computazionali, che richiedono approcci di calcolo parallelo, lo studio di transitori molto lunghi è spesso richiesto. Una strategia che adottiamo è quella di fattorizzare la matrice del sistema lineare utilizzando decomposizioni di Cholesky e applicare soluzioni di sistemi triangolari ad ogni passo temporale. Un altro approccio è la decomposizione agli autovalori, che ha un costo computazionale più elevato rispetto a Cholesky, ma riduce il costo computazionale della valutazione del transitorio.
Agent Based Simulation: La scienza computazionale (CSS) coinvolge campi interdisciplinari e sfrutta metodi computazionali, come l'analisi dei social network e la simulazione al computer con l'obiettivo di comprendere meglio i fenomeni sociali. I modelli basati su agenti (ABM) rappresentano un efficace strumento di ricerca per i CSS e consistono in una classe di modelli che mirano a emulare o prevedere fenomeni complessi attraverso un insieme di regole semplici (ad esempio azioni indipendenti, interazioni e adattamento), eseguite da più agenti. L'efficienza e la scalabilità dei sistemi ABM si ottengono tipicamente distribuendo il calcolo complessivo su più macchine, che interagiscono tra loro per simulare un modello specifico.
Information diffusion in networks: La diffusione dell'influenza nei social network è il processo mediante il quale gli individui adeguano le proprie opinioni, rivedono le proprie convinzioni o modificano i propri comportamenti a seguito delle interazioni con gli altri. Ad esempio, il marketing virale sfrutta l'influenza dei pari tra i membri dei social network per il marketing. L'idea essenziale è che le aziende che vogliono promuovere prodotti o comportamenti potrebbero cercare di prendere di mira e convincere inizialmente alcune persone che poi innescheranno una cascata di ulteriori adozioni. L'intento di massimizzare la diffusione delle informazioni virali attraverso una rete ha suggerito diversi interessanti problemi di ottimizzazione con vari paradigmi di adozione.
Handwriting Analysis: L'atto di scrivere e disegnare a mano è il risultato di una complessa interazione di processi fisici e mentali che coinvolgono diverse abilità cognitive, cinestetiche e percettivo-motorie. In effetti, i testi scritti a mano trasmettono informazioni considerevoli su come funzionano alcune aree del cervello umano. La neurologia, ad esempio, utilizza compiti di scrittura e disegno come metodo non invasivo per diagnosticare e monitorare disturbi come l'Alzheimer e il morbo di Parkinson e disturbi dello sviluppo, tra gli altri. La raccolta della scrittura a mano non è invasiva, semplice ed economica e richiede poca esperienza da parte dell'operatore. Vari test con carta e penna sono stati sviluppati e utilizzati per integrare i dati di laboratorio, l'esame medico o le interviste faccia a faccia. A causa dei numerosi processi coinvolti, la valutazione della grafia si è rivelata molto istruttiva su: disturbi mentali, genere, stati emotivi, tratti della personalità.
Clustering and Classification of multi-valued data: Analisi di dati aggregati in forma di distribuzione con particolare riguardo alle tecniche di Clustering e di Classificazione. Uso di metriche per dati in forma di distribuzione.
Qualitative and quantitative verbal and nonverbal emotional interactional communication features: La domanda e la fornitura di sofisticati strumenti computazionali in grado di riconoscere, elaborare e memorizzare segnali di interazione rilevanti, nonché la capacità di interagire con le persone, mostrando adeguate reazioni autonome opportunamente sensibili ai cambiamenti ambientali, hanno prodotto grandi aspettative nell'Information Communication Technology (ICT). Il progresso verso la comprensione e la modellazione di tali aspetti è cruciale per l'implementazione di sistemi comportamentali di Human Computer Interaction (HCI) che semplificheranno l'accesso degli utenti a servizi sociali futuri, redditizi, remoti e vicini.
Responsabile: Beniamino DI MARTINO
Partecipanti: Aversa ROCCO; Andrea Gaetano CHIARIELLO; Massimiliano RAK; Salvatore VENTICINQUE; Antonio ESPOSITO; Salvatore D’ANGELO; Dario BRANCO; Luigi COLUCCI CANTE; Giacomo DI GUIDA; Pietro FUSCO; Daniele GRANATA; Mariangela GRAZIANO; Angelo AMBRISI; Marta MAURINO; Raffaele PICARO; Martino MONACO; Giuseppe CIRILLO; Adele PASTENA; Paola VIVIANI; Angelo DI FALCO; Alba AMATO; Giuseppina RENDA; Rosanna VERDE; Antonio BALZANELLA; Stefano MARRONE; Anna ESPOSITO; Gennaro CORDASCO; Gennaro Junior PEZZULLO; Domenico DI SIVO.
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Informatica, Laboratorio di Ingegneria del Software ed Intelligenza Artificiale che sono Nodi locali dei seguenti Laboratori Nazionali CINI:
University of Campania Node of the CINI National Laboratory on Big Data
University of Campania Node of the CINI National Laboratory on CyberSecurity
University of Campania Node of the CINI National Laboratory on Smart Cities and Communities
Electric Energy Engineering - Ingegneria dell'energia elettrica
Descrizione linee di ricerca: Il gruppo opera nel campo delle Smart Grids per l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili nelle reti elettriche di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, delle analisi di nuovi convertitori di potenza, della Power Quality e dell'affidabilità dei sistemi elettrici. Questo gruppo si riconosce nel Macro-gruppo Tematico “Energia” della Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.
Le principali linee di ricerca sono:
Modellazione, analisi e gestione delle reti elettriche di trasmissione e distribuzione del futuro: La linea di ricerca ha come obiettivo quello di definire un archivio generale di modelli di riferimento (digital twin) per le future iniziative di ricerca e sviluppo nell’ambito degli studi di Power Quality delle reti elettriche (passive e attive) di trasmissione e distribuzione MT e BT.
Sono stati ottenuti:
- modelli delle configurazioni delle reti tipiche del territorio nazionale;
- modelli di impianti di generazione e di utilizzazione;
- modelli di componenti corredati da database riportanti le rispettive caratteristiche;
- scenari di evoluzione dei sistemi di distribuzione nel prossimo futuro.
Advance Dispatching per il sistema italiano: scopo dell’attività di ricerca svolta in collaborazione con il TSO italiano è realizzare un prototipo, nel contesto del dispacciamento della generazione correntemente operata in Italia, dedicato alle previsioni utilizzabili a brevissimo termine e alla simulazione del funzionamento del sistema elettrico in riferimento alle logiche di ridispacciamento real time delle risorse.
Sono stati ottenuti o sono in fase di studio:
- modelli per la previsione del fabbisogno elettrico della rete di trasmissione nazionale con riferimento al perimetro di mercato;
- modelli per la previsione del fabbisogno elettrico netto, ovvero al netto dell’immesso eolico, solare e da altre fonti energetiche alternative, della rete di trasmissione nazionale sempre con riferimento al perimetro di mercato.
Osmose “Optimal System Mix of Flexibility Solutions for European Electricity”: il gruppo di ricerca ha partecipato, al progetto europeo OSMOSE (28 M€) sul tema della ricerca di soluzioni innovative in campo europeo per un’energia sempre più sostenibile. Il progetto ha visto la partecipazione di 33 Partner Europei selezionati tra i più importanti player internazionali nel campo dell’energia elettrica, che in Italia ha visto la presenza di TERNA ed ENEL, e tra il mondo universitario, che in Italia era rappresentato da alcune sedi del Consorzio EnSiEL, di cui il responsabile del gruppo di ricerca e referente locale. L’obiettivo è stato quello di studiare metodologie e strumenti per fare in modo che la produzione da fonti rinnovabili sia effettivamente utilizzabile sulla rete aumentando la flessibilità della rete e del sistema elettrico nel suo complesso, ossia la sua capacità di adattare l’offerta alle variazioni della domanda.
Responsabile: Roberto LANGELLA
Partecipanti: Muhammad AWAIS; Muhammad ISHAQ; Adam John COLLIN; Luigi RUBINO; Alfredo TESTA.
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Elettronica di Potenza, Laboratorio di Sistemi Elettrici
Electromagnetic Diagnostics - Diagnostica Elettromagnetica
Descrizione linee di ricerca: L’attività di ricerca verte sull’applicazione alla diagnostica delle antenne di metodologie matematiche dei problemi inversi e dell’elaborazione dei segnali. Per le antenne ad array, sono stati applicati algoritmi di proiezione su sottospazi. Per le antenne ad apertura, è stata esaminata una tecnica di trasformazione dell’operatore di radiazione che consente di introdurre un grigliato di misura ottimale non uniforme. In questo modo si attingono i gradi di libertà del campo radiato. L’analisi è stata anche estesa al campo diffuso da oggetti per applicazioni di prospezione subsuperficiale. Lo studio dei gradi di libertà è stato esteso anche ad una sorgente conforme per determinare il numero e la posizione ottimale sia dei punti di misura che degli elementi di un array. Per la diagnostica di antenne dal solo modulo del campo vicino, è stata investigato il ruolo dei dati indipendenti sull’affidabilità dell’algoritmo di minimizzazione affetto dalla presenza di minimi locali in relazione al numero di incognite da cercare relative alla sorgente.
Responsabile: Giovanni LEONE
Partecipanti: Adriana BRANCACCIO; Maria Antonia MAISTO; Raffaele SOLIMENE.
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Campi elettromagnetici
Energy Engineering - Ingegneria dell'Energia
Descrizione linee di ricerca: Il gruppo di ricerca "Ingegneria dell'Energia " è composto complessivamente da 22 ricercatori attivi presso il Dipartimento di Ingegneria (DI) e accomunati dall'aver svolto nel triennio 2021-2023 attività di ricerca interdisciplinari nel campo dell'Ingegneria dell'Energia. Le principali linee di ricerca sono:
- “Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili”,
- "Smart Grids per l'integrazione della Generazione Distribuita di Energia da Fonti Tradizionali e Rinnovabili nelle reti elettriche per l'Energia ",
- “Biomasse residuali per la produzione di biogas, utilizzo in motori a combustione interna e controllo degli inquinanti della combustione”,
- "Metrologia per l’Energia",
- "Distributed Software Smart Agent Systems to Support Collaborating smart solar powered microgrids".
Linea di ricerca 1: “Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili”: L’attività di ricerca inquadra una serie di temi accomunati dallo sviluppo di metodologie e strumenti di analisi e progetto per le fonti di energia rinnovabili. Presso il dipartimento, sono attivamente investigate le tecniche di modellazione e le tecnologie per la produzione e lo sfruttamento di energia:
- Eolica,
- Solare (sia nella forma del solare fotovoltaico che termico),
- Marina,
- da Idrogeno.
Un importante fonte di energia, accomunabile per molti aspetti alle rinnovabili, è la Fusione Termonucleare Controllata, su cui la ricerca dei membri del dipartimento è attiva da molti anni. Si rimandia alla lista delle pubblicazioni per ogni dettaglio sui singoli temi.
Linea di ricerca 2: "Smart Grids per l'integrazione della Generazione Distribuita di Energia da Fonti Tradizionali e Rinnovabili nelle reti elettriche per l'Energia": L’attività è rivolta all'integrazione della generazione distribuita di energia da fonti tradizionali e rinnovabili nelle reti elettriche per l'energia per lo sviluppo delle Smart Grids. Il contributo dei ricercatori del DI è stato principalmente indirizzato ai temi: affidabilità di reti, componenti e sottosistemi elettrici; Smart Metering and sensors; misure e analisi di Power Quality; convertitori innovativi per l’interfacciamento di sistemi di generazione e di accumulo e per il filtraggio attivo; gestione e ottimizzazione di sistemi di accumulo e di carichi.
Linea di ricerca 3 : "Biomasse residuali per la produzione di biogas, utilizzo in motori a combustione interna e controllo degli inquinanti della combustione": L’attività è focalizzata sui processi di produzione di bio-idrogeno e metano da fermentazione anaerobica di biomasse residuali. Le attività indagano i parametri di processo per l’ottimizzazione della fermentazione quali yield di biogas prodotto, di composizione e di cinetiche di reazione. Le esperienze in reattori batch hanno fornito valori di idrogeno prodotto pari a circa il 15% e 60% per il metano. Altra attività è stata il controllo delle emissioni inquinanti da processi di combustione, principalmente formate da SO2, NOx, CO, idrocarburi incombusti e Particolato (PM). Quest’ultimo è più dannoso quanto più piccole sono le sue dimensioni. Le efficienze di rimozione sono superiori al 90% per particelle micrometriche, e molto più basse per dimensioni sub-micrometriche. L’attività è incentrata sullo studio, teorico e sperimentale, del Water Electrostatic Scrubbing (WES) un nuovo processo per la rimozione ad alta efficienza di particolato submicronico. Il WES prevede il lavaggio di correnti gassose, contenenti particolato, mediante spray elettrificati di acqua. Le interazioni elettrostatiche consentono di portare l’efficienza di cattura del particolato submicronico fino a valori superiori al 90.Il WES rimuove simultaneamente anche inquinanti gassosi mediante assorbimento.
Linea di ricerca 4: "Metrologia per l’energia": La linea di ricerca riguarda lo studio e lo sviluppo anche sperimentale dei principali dispositivi, tecniche e tecnologie di misura inerenti la gestione e l’analisi dell’energia e della sua qualità. In particolare, in quest’ambito sono state sviluppate attività di ricerca su:
- Monitoraggio di potenza ed energia e qualità dell’alimentazione elettrica in regime non sinusoidale,
- Analisi di problemi di qualità dell’alimentazione elettrica (Power Quality),
- Ottimizzazione dei consumi energetici nei sistemi industriali e ferroviari,
- Demand Side Management in reti di distribuzione intelligenti,
- Sistemi di misura e controllo per l’ottimazione dei consumi energetici nei sistemi industriali e di trasporto ferroviario,
- Progettazione, realizzazione e caratterizzazione di trasduttori di tensione e corrente della rete elettrica in regime non sinusoidale e dissimmetrico,
- Progettazione, realizzazione e caratterizzazione di sensori evoluti (smart sensors) delle principali grandezze elettriche,
- Progettazione, realizzazione e caratterizzazione di contatori intelligenti (smart meter) per smart grid elettriche,
- Progettazione, realizzazione e caratterizzazione di dispositivi, tecniche e tecnologie di misura inerenti lo sviluppo dello sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.
Linea di ricerca 5: “Distributed Software Smart Agent Systems to Support Collaborating smart solar powered microgrids”: L'attività di ricerca è incentrata sullo studio e sviluppo di modelli e tecniche per la realizzazione di soluzioni ICT innovative per la gestione collaborativa dei consumi e della produzione decentralizzate di energia. Al fine di ottimizzare l’utilizzo e l’immagazzinamento dell'energia in micro-grids tecniche di simulazione e modelli ad agenti per il calcolo distribuito. Esempi di applicazioni sono il monitoring distribuito di sistemi IoT, per la misura del consumo di potenza livello delle singole appliances, la valutazione delle abitudini degli utenti riguardo al consumo di energia, la misura e la predizione della produzione di energia dai pannelli solari, ed altri fattori ambientali (e.g. le previsioni del tempo locali), la ricarica intelligente di veicoli elettrici.
Responsabile: Furio CASCETTA
Partecipanti: Roberto LANGELLA; Alfredo TESTA; Alessandro FORMISANO; Massimo VITELLI; Andrea Gaetano CHIARIELLO; Biagio MORRONE; Claudia CAROTENUTO; Carmine LANDI; Daniele GALLO; Mario LUISO; Antonio DELLE FEMINE; Oronzio MANCA; Sergio NARDINI; Bernardo BUONOMO; Beniamino DI MARTINO; Rocco AVERSA; Salvatore VENTICINQUE; Diego VICINANZA; Claudio IODICE; Raffaella GRIFFO; Muhammad ISAHQ; Michele De Santis.
Environmental Design - Progettazione Ambientale
Descrizione linee di ricerca:
L'ambito scientifico attiene alle teorie, metodologie e tecniche operative del progetto sostenibile, dalla scala dell'edificio a quella territoriale, integrando le diverse competenze della tecnologia dell'architettura, della progettazione ambientale, del design, della progettazione architettonica, della pianificazione, della sociologia, della geologia, della geomorfologia, dell’idraulica, della tecnica delle costruzioni. Tra gli obiettivi del gruppo vi è l’offerta di supporto teorico, metodologico e operativo per la definizione dei requisiti di eco-compatibilità nei processi progettuali, così come la focalizzazione del contributo che l’innovazione nei diversi settori scientifici e culturali può apportare alle trasformazioni dell’ambiente. Le ricerche dei membri componenti il gruppo, relativamente agli specifici disciplinari, sono strutturate considerando parametri ambientali per la trasformazione dei siti in sintonia con l'ecosistema di appartenenza, in funzione della massima mitigazione possibile degli impatti e dell'attivazione di buone pratiche. Tra queste ultime, uno dei focus è la cura delle interrelazioni tra persone, contesto naturale e costruito, aiutando a creare ambienti rispondenti alle esigenze degli utenti. La ricerca ha carattere sia sperimentale che teorico; il gruppo ha un’ampia produzione scientifica, documentata da articoli su importanti riviste e journal, libri e capitoli di libri, paper in atti di convegni internazionali.
I principali interessi scientifici interdisciplinari comuni tra i vari partecipanti al gruppo riguardano le cinque linee di ricerca di seguito descritte.
- Le teorie e l'epistemologia del progetto ambientale. Indagando sulla storia della progettazione sostenibile e sulle riflessioni in merito alle sue influenze, motivazioni e derivazioni, si studiano l’evoluzione dei processi operativi e le connessioni con la filosofia della scienza e della tecnica, anche in riferimento al concetto di pratica riflessiva. Le catalogazioni, i processi innovativi, le metodologie, i modelli e le famiglie di obiettivi sono tra gli esiti del lavoro di ricerca.
- La riqualificazione delle aree spondali sui bordi del mare e delle acque interne. In relazione allo studio dei sistemi per la corretta gestione degli equilibri idrologici, l’approfondimento sulle dinamiche evolutive naturali ed artificiali delle aree di transizione tra terra, acqua e aria consente di descrivere potenziali scenari di trasformazione in sintonia con l’ecosistema di riferimento. Ciò permette di ipotizzare strategie per la riqualificazione sostenibile del costruito, la tutela attiva dello spazio aperto e la protezione delle linee di costa in erosione, attraverso sistemi che utilizzino le dinamiche naturali per ricostituire paesaggi degradati.
- La riqualificazione ecocompatibile delle infrastrutture grigie, verdi e blu. Questa tematica profondamente interscalare è attenta allo studio delle reti ambientali e artificiali per il recupero sostenibile delle connessioni esistenti o potenziali. Lo sguardo critico indaga sulle linee dismesse come a quelle in esercizio, per la rifunzionalizzazione e la riattivazione degli scambi osmotici, materici e di flussi lungo le aste e i nodi. In tale ambito si fa ricerca in merito ai sistemi basati sulla natura ed alle reti di drenaggio naturale delle acque meteoriche, anche progettando le componenti innovative di elementi artificiali ad esso connesse.
- Le strategie per la rigenerazione urbana e la progettazione di quartieri sostenibili. L’ambito di ricerca concerne le teorie, le metodologie ed i protocolli innovativi per il recupero della vivibilità della città e delle sue parti. Nell’applicare metodiche di lettura ambientale basate su indicatori e considerazioni interdisciplinari complesse, si integrano analisi quantitative e qualitative. La possibilità di classificare le caratteristiche dei luoghi in esame consente di definire criticità e potenzialità a cui fare corrispondere network di attrezzature responsive con le dinamiche socio-tecniche attive. Indagando sugli aspetti degli ecoquartieri, si studiano anche approcci quali l’Urban greening come strumento per il ridisegno di manufatti e spazi aperti. L’interscalarità propria del tema si esprime dallo studio dei regolamenti tecnici degli strumenti di pianificazione esecutiva, all’indagine sui requisiti di ecocompatibilità del tessuto costruito sino agli studi per il design di sistemi reversibili e interattivi diffusi sul territorio.
- La sperimentazione progettuale innovativa sui manufatti edilizi. La linea di ricerca studia l’evoluzione del progetto e della produzione di nuovi sistemi, componenti, elementi e materiali per la costruzione ed il recupero sostenibili. L’attenzione è rivolta all’uso di materie seconde, al design for disassembling, al prolungamento del ciclo di vita di strutture e componenti, alla protezione dai rischi sismici, di incendio e da tossicità. Si indaga sul potenziamento della strategia di progetto degli edifici passivi, sulla riduzione del fabbisogno e sull’autoproduzione di energia, insieme con la gestione sostenibile dell’acqua, il confort acustico e termoigrometrico, la qualità dell’aria.
Responsabile: Renata VALENTE
Partecipanti: Alberto Maria AVOSSA; Assunta CAPECE; Armando DI NARDO; Carlo DONADIO; Massimiliano FERRAIOLI; Francesca LA ROCCA; Salvatore LOSCO; Alberto MANDARA; Massimiliano RENDINA; Francesco RICCIARDELLI; Annamaria RUFINO; Louise A MOZINGO; Kristina HILL; Fernando MAGDALENO MAS; Sergio ALTOMONTE; Mariano SIDRACH DE CARDONA ORTIN; Roberto BOSCO; Luca LÄMMLE, Antonio MALASOMMA, Osvaldo PECORARI; Vincenzo PICOZZI; Savino GIACOBBE; Cipriano CERULLO.
From Industrial City Spatial Planning to Contemporary Territories Eco-Planning - Dalla Pianificazione urbanistica della Città Industriale all’Eco-Planning dei Territori della Contemporaneità
Descrizione linee di ricerca: I cambiamenti ambientali, correlati al climate change, in atto alle varie scale e gli effetti ad essi associati determinano varie forme di pericolosità naturali e artificiali che coinvolgono in modo pervasivo insediamenti sempre più antropizzati sottoponendoli a varie tipologie e grado di intensità di rischi territoriali. Il gruppo di ricerca articola le proprie attività secondo varie linee di ricerca, con l’obiettivo comune di sviluppare teorie e tecniche finalizzate all’innovazione dell’analisi, pianificazione, progettazione e gestione del territorio, alle varie scale, per contribuire alla transizione delle discipline tradizionali della pianificazione fisica verso l’Eco-Planning. In questo quadro scientifico si collocano alcune attività di ricerca riferibili in modo più specifico alle seguenti problematiche: antropizzazione dilagante del territorio, abusivismo urbanistico/edilizio, nuove popolazioni, consumo di suolo, fenomeno dell’isola urbana di calore, gestione sostenibile delle acque in ambiente antropizzato, produzione e consumo di fonti energetiche rinnovabili in ambiente antropizzato, mobilità sostenibile. A tal fine l’indagine su densità e forma urbana, acqua e principio di invarianza idrologica ed idraulica, biodiversità, energia, rifiuti e mobilità rappresenta una possibile scomposizione, in sottosistemi più semplici, della complessità sistemica insita nella sostenibilità dei territori contemporanei.
In particolare, le principali linee di ricerca interdisciplinari caratterizzanti gli interessi di ricerca dei partecipanti al gruppo sono le seguenti:
- Urban and Regional Eco-Planning
L’irruzione della dimensione ambientale nella pianificazione territoriale/urbana e nelle discipline del progetto di territorio ha esaltato alcune contraddizioni di fondo preesistenti, ha posto in discussione alcune acquisizioni disciplinari che hanno supportato la teoria e la prassi negli ultimi decenni imponendo una revisione critica e/o una rifondazione di alcuni assiomi ormai parte della cassetta degli attrezzi della pianificazione dello spazio fisico. L’obiettivo fondamentale consiste nell’individuazione delle teorie e tecniche per pianificare, progettare, trasformare e gestire insediamenti più sostenibili sia che si tratti di quartieri prevalentemente residenziali che di aree produttive ecologicamente attrezzate. Il focus principale è sulle nuove tecniche urbanistiche che si sostanziano nella sintesi ambientale tra scienza del territorio, norma amministrativa ed economia dello spazio.
- Architecture and Built Environment
Il gruppo si interessa degli aspetti costruttivi dell'edilizia - materiali, elementi, componenti, sistemi e processi - e delle loro implicazioni nella definizione del progetto di architettura e nella trasformazione sostenibile dell'ambiente naturale e costruito. L’attività di ricerca, teorica e sperimentale, del gruppo si svolge anche nel LABTECH e nei laboratori di idraulica e geotecnica. La specifica attività scientifica del gruppo è riconducibile, principalmente, alle seguenti linee di ricerca: tipologie edilizie, tecnologie costruttive con riferimento anche allo studio e alla sperimentazione in laboratorio e in situ di materiali e metodi di indagine, analisi dei dati e modellazione, influenza di tipologia e tecnologia sulla definizione del paesaggio urbano, tecnologie edilizie e sistemi costruttivi nel loro sviluppo storico.
- Mobilità sostenibile
Il gruppo di ricerca si interessa di mobilità sostenibile delle città e dei territori, ovvero garantire alle persone e alle merci la possibilità di spostarsi in libertà, comunicare e stabilire relazioni senza però perdere di vista l’aspetto umano, economico ed ambientale, oggi come in futuro. Le aree di ricerca prevalenti su questa tematica includono: i metodi di valutazione degli investimenti nel settore dei trasporti (es. analisi costi benefici e multicriteriali); la redazione di piani e programmi di investimento nel settore dei trasporti alle differenti scale territoriali (es. nazionale, regionale, locale); i modelli e metodi per la simulazione dei sistemi di trasporto delle merci e dei passeggeri (es. analisi della domanda e offerta di trasporto); la pianificazione e progettazione di politiche e servizi urbani di mobilità sostenibile (es. car sharing, piste ciclabili, riduzione parcheggi, aree car free, servizi Mobility as a Service -MaaS, qualità nel trasporto collettivo); la decarbonizzazione del settore dei trasporti (es. targets EU, Agenda ONU 2030).
- Rilievo e Sistemi Informativi Territoriali
L’utilizzo sinergico delle tecniche di Telerilevamento e sistemi informativi territoriali è importantissimo per la gestione di un ampio insieme di problematiche legate all’ambiente e al territorio. L’attività di ricerca si baserà sulla lettura ed interpretazione di immagini satellitari per l’analisi mutitemporale, multifrequenziale e multiscalare dei cambiamenti, con particolare attenzione alla mappatura dell’uso del suolo (Land Use- Land Cover, LU-LC), da cui si derivano appropriate metriche del paesaggio (landscape metrics), a supporto del monitoraggio del territorio, e alla integrazione dei risultati in ambiente GIS/SIT. I dataset multitemporali a disposizione per questo tipo di analisi provengono da disparate missioni di remote sensing satellitare (Landsat, Sentinel, WorldView, QuickBird, ecc.), ma anche da ortofoto e foto aeree disponibili su vari siti istituzionali, e permetteranno una comprensione su piccola, media e larga scala spazio-temporale delle dinamiche dei cambiamenti, naturali e antropici, fornendo strumenti sulla pianificazione, gestione e monitoraggio dei dati ambientali.
- Nuova morfologia sociale della comunità insediata contemporanea
Analisi e comprensione dei mutamenti sociali della comunità insediata e della domanda di territorio che esprime. Le dinamiche urbanistiche non possono non essere connesse con quelle sociali. Gli eventi emergenziali di questi ultimi anni non solo hanno accentuato le criticità pregresse, ma ne hanno evidenziato di nuove. In questo senso attenzionare l’interazione tra sistema urbano e sistema sociale diviene imprescindibile.
Responsabile: Salvatore LOSCO
Partecipanti: Claudia de BIASE; Marco CALABRÒ; Armando CARTENÌ; Cipriano CERULLO; Gaetano CRISPINO; Nicola CROCETTO; Fabiana FORTE; Sara GONIZZI BARSANTI; Luigi MOLLO; Luigi MACCHIA; Salvatore PONTE; Massimiliano RENDINA; Annamaria RUFINO; Renato ZONA.
Geo-hydrological risk and effects of climate change - Rischio geo-idrologico ed effetti del cambiamento climatico
Descrizione linee di ricerca: Le attività di ricerca del gruppo riguardano la valutazione della pericolosità e del rischio geo-idrologico, con particolare riferimento all’influenza delle forzanti climatiche a breve ed a lungo termine, ed ai metodi strutturali e non strutturali per la gestione/mitigazione del rischio geo-idrologico e la protezione del territorio da frane e alluvioni. Specificamente, le principali linee di ricerca sono le seguenti:
- Previsione di eventi idrologici estremi;
- Analisi dei meccanismi di frana in terreni e rocce;
- Sviluppo di modelli di previsione di piene, alluvioni e flussi iperconcentrati;
- Modellazione dell’interazione suolo-pianta-atmosfera a diverse scale;
- Sviluppo di sistemi innovativi per il monitoraggio geo-idrologico;
- Analisi e mappatura di pericolosità geo-idrologica;
- Sviluppo di sistemi di allerta;
- Studio dell’interazione tra frane e manufatti;
- Sviluppo di sistemi per la mitigazione del rischio di frana;
- Sviluppo di sistemi per la mitigazione del rischio idraulico;
- Analisi dei principali fattori di suscettibilità a frana del territorio;
- Analisi degli effetti del cambiamento climatico sulla pericolosità geo-idrologica;
- Analisi degli effetti del cambiamento di uso del suolo sulla pericolosità geo-idrologica.
Responsabile: Roberto GRECO
Partecipanti: Luca COMEGNA; Emilia DAMIANO; Michele IERVOLINO; Alessandro MANDOLINI; Mario MINALE; Lucio OLIVARES; Daniela RUBERTI; Giovanni Francesco SANTONASTASO; Luigi ZENI; Pasquale MARINO.
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Geotecnica, Laboratorio di Chimica, Microgravità e Reologia, Laboratorio di Strutture Civili, Laboratorio di Optoelettronica, Laboratorio di Cartografia Territoriale, Laboratorio di Geopedologia
Geosciences for Sustainable Development - Geoscienze per lo Sviluppo Sostenibile
Descrizione linee di ricerca:
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (ONU) definisce 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS). Riteniamo che la ricerca e la pratica geologica possano contribuire a raggiungere tutti gli OSS in quanto essi richiedono una migliore gestione delle risorse naturali (terra, energia, acqua, minerali). La comprensione dei processi della Terra permette che le persone, le attività umane e le infrastrutture siano resilienti ai cambiamenti ambientali e ai rischi geologici. Il gruppo di ricerca si concentra sui processi del sottosuolo fondendo approcci geologici, geochimici e geofisici.
Modello geologico del sottosuolo
La conoscenza capillare 3D del sottosuolo e delle sue caratteristiche geologiche e pedologiche permette di definire i fattori fisico-ambientali che si intersecano con quelli antropici nel determinare lo sviluppo del territorio. In questo, risulta particolarmente significativo lo studio e la caratterizzazione del sottosuolo della Piana Campana per la sua peculiare configurazione geologica e la possibilità di definire modelli di riferimento. La geometria del bacino in profondità, la tipologia dei depositi di riempimento sedimentario e/o vulcanico e l’architettura deposizionale sono alla base dei noti fenomeni di subsidenza e possono anche riflettere lo stile e la velocità di deformazione a lungo termine del sistema di faglie che bordano il bacino. Pertanto la ricostruzione delle caratteristiche geologiche e geotecniche di questi bacini, dalla morfologia del substrato allo spessore del riempimento, sono elementi chiave per la pianificazione di opere e infrastrutture e per lo studio dell’evoluzione tettonica e di quella paleoclimatica e paleogeografica. L’obiettivo è la realizzazione di un modello geologico tridimensionale della geometria del substrato e dei depositi di riempimento che vada a supportare e a integrarsi con i dati relativi alla geologia di superficie, alle misure geofisiche strumentali. Tra le specificità in esame, la mappatura di cavità sotterranee di origine antropica nel sottosuolo nelle aree urbane che rappresenta un grave problema soprattutto dove la crescita delle città ne ha oscurato la conoscenza. Lo studio di questi vuoti aiuta a mitigare il rischio geologico e offre opportunità di recupero e valorizzazione laddove questi rappresentino testimonianze di secolari attività antropiche. Inoltre, in chiave green, rappresentano sistemi di serbatoi geotermici a bassissima entalpia per la climatizzazione mediante pompe di calore geotermiche.
Georisorse, energia e rischi
La ricerca e lo sfruttamento del sottosuolo sono strettamente connessi al dettaglio conoscitivo che abbiamo di esso e dei suoi processi chimici e fisici passati e presenti ai fini 1) della produzione primaria di risorse (fluidi geotermici) e materie prime non energetiche (acque dolci sotterranee, minerali metallici, industriali e strategici) e 2) dell’utilizzo del sottosuolo per aspetti energetici e confinamento fluidi. La conoscenza chimico-fisica del sottosuolo è fondamentale per progetti innovativi di sfruttamento delle basse e medie entalpie (climatizzazione ecocompatibile e produzione di energia elettrica ad impatto zero) e la geosequestrazione dei gas climalteranti. In Campania il sottosuolo vulcanico è il reame dell’interazione acqua-gas-roccia dove elementi critici come i metalli sono abbondanti e in certe condizioni anche disponibili. Tutta questa ricchezza ha tuttavia un costo: a) forme di inquinamento geogenico possono incidere sui suoli e sulla vulnerabilità dei corpi idrici in particolare di quelli più profondi e quindi più strategici per le prossime generazioni, mentre b) gli alti regimi termici del sottosuolo in molti settori della nostra regione sono associati a fenomeni geofisici, vulcanici e sismici che impattano sulla vita dei cittadini, come nel caso del bradisisma dei Campi Flegrei. La caratterizzazione e lo studio delle risorse geotermiche e minerali del sottosuolo permette quindi di identificare efficaci strategie di monitoraggio e controllo, per il recupero e migliore sfruttamento e utilizzo delle risorse del sottosuolo ai fini della transizione energetica e della valutazione della pericolosità e dei rischi causati dai fenomeni endogeni.
Responsabile: Roberto MORETTI
Partecipanti: Daniela RUBERTI; Eugenio RUOCCO; Marco VIGLIOTTI; Carla BUFFARDI; Maria Laura FABBOZZI; Naveed ULLAH; Monica PIOCHI (INGV-OV); Ilenia ARIENZO (INGV-OV); Philip S J MINDERHOUD (WUR - NL); Marian MARSCHALKO (Czech Republic); Luigi TOSI (IGG-CNR); Pietro TEATINI (Unipd); Luigi BRUNO (Unimore); Mario PARISE (Uniba).
Image Processing and Optical Microwave Sensors - Elaborazione delle immagini e sensoristica ottica e a microonde
Descrizione linee di ricerca:
Sensoristica a microonde. Le tematiche di ricerca sono relative allo sviluppo di metodi e sensori per la diagnostica elettromagnetica. In particolare, esse riguardano l'analisi e la misura di antenne a larga e larghissima banda (UWB) (sensori intelligenti) operanti in scenari complessi, lo sviluppo di modelli di diffusione elettromagnetica e la relativa implementazione mediante codici computazionalmente efficienti, lo sviluppo di algoritmi per il monitoraggio ambientale e di strutture per l'ingegneria civile, la prospezione subsuperficiale tramite georadar e il Through-Wall-Imaging, la tomografia a microonde ed a onde millimetriche per la caratterizzazione dei materiali e per l’imaging biomedicale per la diagnostica del tumore al seno e la rilevazione di fratture ossee.
Sensoristica ottica. La tematica prevede lo sviluppo ed il progetto di dispositivi e nanostrutture per la realizzazione di sensori optoelettronici, sensori basati su superconduttori ad alta temperatura critica e biosensori integrati e in fibra ottica per la diagnostica clinica ed ambientale; il progetto e lo sviluppo di sensori in fibra ottica per diagnostica ed il monitoraggio di grandi strutture (smart structures) dell’ingegneria civile utili alla identificazione precoce di eventuali danni, cedimenti ed in grado, quindi, di costituire un sistema di allarme e allerta permanente.
Elaborazione di immagini. La tematica prevede attività nel campo della elaborazione intelligente di immagini per sorveglianza in scenari complessi, quali porti e interporti, tramite la modellizzazione con metodi stocastici Bayesiani di oggetti in movimento, con particolare riferimento alle problematiche di tracking, di riconoscimento e di classificazione di situazioni critiche.
Responsabile: Giovanni LEONE
Partecipanti: Francesco PALMIERI; Luigi ZENI; Adriana BRANCACCIO; Aldo MINARDO; Raffaele SOLIMENE; Gianmarco ROMANO; Nunzio CENNAMO; Maria Antonia MAISTO; Alessandro Lo SCHIAVO; Giovanni DI GENNARO.
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Campi Elettromagnetici, Laboratorio di Elettronica, Laboratorio di ICT (Information, Communication, Technology)
Progetto di ricerca: MIT
Il progetto di ricerca MIT (Microwave Imaging via Temnography) è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania, nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020. CUP: B13D18000100007.
Il progetto ha come scopo lo sviluppo di un sistema temnografico per la rivelazione dei tumori al seno che quindi fornisca una tecnologia innovativa per la diagnostica medica.
Progetto di ricerca: HT
Il progetto di ricerca HT (HEAD TEMNOGRAFY: NEW DIAGNOSTIC MICROWAVE FOR HEAD DESEAS) è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania, nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020. CUP: B13D18000150007
Il progetto ha come scopo lo sviluppo di un sistema diagnostico basato sull'uso delle onde elettromagnetiche alle frequenze delle microonde per la rivelazione precoce degli ictus.
Innovative and Sustainable Strategies of Seismic Protection - Strategie Innovative e Sostenibili di Protezione Sismica
Descrizione linee di ricerca: Le attività di ricerca del gruppo riguardano lo studio, lo sviluppo e la messa a punto di strategie, sistemi, e tecnologie per la protezione sismica del territorio e dell’ambiente antropizzato. Le soluzioni oggetto di studio intendono soddisfare i requisiti connessi non solo alla prestazione in senso strettamente tecnico, ma anche le attuali esigenze in termini di sostenibilità ed ecocompatibilità.
Il gruppo è articolato sulle seguenti linee di ricerca:
Protezione delle costruzioni. La linea di ricerca si propone lo studio di materiali, tecniche e strategie innovative di intervento per la protezione sismica delle costruzioni basate non soltanto su tradizionali requisiti di rigidezza, resistenza e duttilità, ma anche sulla resilienza, intesa come capacità di riprendere rapidamente la completa funzionalità a seguito di un evento di tipo sismico. L’esperienza di eventi sismici anche recenti ha inoltre evidenziato l’estrema vulnerabilità di strutture e infrastrutture strategiche e rilevanti che, invece, dovrebbero mantenere integra la loro piena funzionalità per il ruolo che svolgono per le finalità di protezione civile. L’obiettivo è pertanto quello di sviluppare sistemi di protezione sismica di facile implementazione, a basso impatto e reversibili, che possano essere agevolmente rimossi, sostituiti, ed integrati, e che incrementino la resilienza sismica, limitando così i costi, i tempi e l’invasività degli interventi, in modo garantirne la fattibilità e la sostenibilità. In tale contesto si prevede di dare particolare enfasi allo studio di materiali e soluzioni ecocompatibili da sviluppare in armonia con i principi dell’economia circolare. La linea si rivolge a tutte le principali tipologie costruttive presenti in campo civile ed industriale, che includono: edifici per uso abitativo con struttura a telaio oppure a pareti; edifici ed altre strutture per uso industriale; edifici e altre strutture di tipo strategico; strutture speciali; ponti; infrastrutture idrauliche; etc.
Protezione del territorio. Tale linea di ricerca è rivolta alla protezione del territorio nella sua duplice natura di ambiente naturale ed antropizzato. Essa affronta pertanto problematiche indirizzate, da un lato, alla valutazione della pericolosità da instabilità sismo-indotta in pendii naturali ed artificiali attraverso l’impiego di metodi innovativi e alla ricerca di metodi avanzati di tipo strutturale e non strutturale finalizzati alla mitigazione del rischio connesso. Allo stesso tempo, essa mira alla messa a punto di una serie di procedure per la valutazione della vulnerabilità sismica e del danno su scala edilizia e su scala urbana con la finalità di pervenire ad una valutazione globale della vulnerabilità sismica di intere aree territoriali. In tale contesto convergono competenze interdisciplinari necessarie per la caratterizzazione geologica e geotecnica dei siti interessati, l’analisi dei meccanismi di innesco o riattivazione dei fenomeni franosi e delle corrispondenti caratteristiche cinematiche post-rottura, il monitoraggio dei parametri precursori ed indicatori, lo studio dei meccanismi di interazione tra il corpo di frana e le opere strutturali ed infrastrutturali coinvolte, la stima della vulnerabilità del bene esposto (umano, economico e sociale). Viste le specificità del territorio Campana, in questa linea si affrontano anche e tematiche connesse al bradisismo, ovvero l’occorrenza di sismi di bassa magnitudo e profondità in aree fortemente antropizzate in relazione ad eventi deformativi del suolo di medio e lungo periodo. In maniera analoga, la linea intende affrontare la necessità emergente dalla domanda della comunità insediata di migliorare/valorizzare la sicurezza del territorio attraverso un’analisi non esclusivamente quantitativa ma anche prestazionale, finalizzata alla mitigazione del rischio sismico attraverso la riduzione della vulnerabilità del costruito.
Risposta sismica locale ed interazione terreno-struttura. Tra le lezioni apprese dai terremoti che hanno recentemente colpito il territorio nazionale, vi è sicuramente quella riguardante gli effetti locali in relazione alle particolari caratteristiche dei manufatti coinvolti dal sisma. Tali effetti, definibili anche come effetti di sito, hanno infatti dimostrato di giocare un ruolo fondamentale sulla vulnerabilità sismica delle costruzioni, richiamando l’attenzione sulla necessità di un approccio integrato che prenda in considerazione la risposta complessiva del sistema terreno-struttura. La linea di ricerca si incentra pertanto sullo studio del comportamento sismico dei terreni, nonché sull’interazione tra il terreno e gli elementi strutturali in contatto con esso, con particolare riferimento all’influenza che tale interazione riveste sulla risposta della struttura in elevazione. Il Gruppo è impegnato, in collaborazione con altri gruppi di ricerca internazionali, in un’ampia attività di ricerca di tipo analitico, numerico e sperimentale, con la finalità di mettere a punto metodologie semplificate e affidabili di analisi e progettazione che possano garantire elevati standard di protezione sismica.
Tecnologie circolari per l’Ingegneria Sismica. Le tecnologie circolari costituiscono un approccio innovativo che, sulla base dei principi dell'economia circolare, mira a creare e implementare soluzioni sostenibili e resilienti. Tale linea si presenta pertanto fortemente interconnessa con le precedenti in modo da garantire la piena sostenibilità delle soluzioni proposte dal punto di vista ambientale ed economico. Ciò è coerente con lo spirito dell’economia e delle tecnologie circolari che, a differenza delle tecniche tradizionali rivolte principalmente alla progettazione di strutture e sistemi atti a resistere alle forze sismiche, si pongono l'obiettivo di migliorare la resilienza del costruito, promuovendo in tal modo anche lo sviluppo sostenibile dell'industria AEC italiana. Le tecnologie circolari consentono anche di massimizzare l'efficienza degli investimenti nel settore attraverso l'implementazione di soluzioni finalizzate ad ottenere i massimi rendimenti o risultati possibili, ottimizzando l'uso delle risorse e riducendo al minimo gli sprechi. Considerazioni analoghe possono essere estese anche alla prestazione energetica e ad altri indicatori complessi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che determinano l’abitabilità/agibilità del patrimonio edilizio, e che possono pertanto utilmente avvalersi del contributo offerto dalle tecnologie circolari.
Responsabile: Alberto MANDARA
Partecipanti: Alessandro MANDOLINI, Francesco RICCIARDELLI, Alberto D’AMORE, Massimiliano FERRAIOLI, Luca COMEGNA, Raffaele DI LAORA, Luigi MOLLO, Alberto Maria AVOSSA, Vincenzo MINUTOLO, Eugenio RUOCCO, Roberto MORETTI, Daniela RUBERTI, Salvatore LOSCO, Alfonso MARINO, Luigi GRASSIA, Chiara IODICE.
Innovative Technologies for Environment Protection from Pollution and Sustainable Resource Use - Tecnologie innovative per la protezione dell’ambiente dall’inquinamento e l’utilizzo sostenibile delle risorse – InnoTEP
Descrizione linee di ricerca:
Tecniche avanzate per la decontaminazione di acque contaminate – Advanced technique for water quality protection and pollutant removal: I processi di depurazione delle acque richiedono tecnologie sempre più efficaci a seguito dell’irrigidimento della normativa a tutela dell’ambiente. Notevole interesse viene posto nei confronti degli inquinanti prioritari e persistenti e dei così detti “contaminanti emergenti”, definiti tali in quanto non normati o in fase di valutazione di valori limite, per i quali grande preoccupazione è manifestata dalla comunità scientifica internazionale per la capacità di accumularsi nella catena alimentare e per i potenziali effetti tossici sull’ambiente e sulla salute. La rimozione di tali inquinanti richiede l’impiego di tecniche avanzate, in particolare l’attività di ricerca è incentrata nello studio, sia da un punto di vista cinetico che termodinamico, di: adsorbimento e processi avanzati di ossidazione (fotodegradazione, ossidazione elettrochimica, cavitazione).
Tecnologie di bonifica di suoli e acque sotterranee contaminati – Soil-groundwater remediation technologies: Le barriere permeabili adsorbenti sono considerate una promettente tecnologia di bonifica di siti inquinati. Tali barriere sono costituite da un setto di opportuno materiale granulare, posto ortogonalmente rispetto alla naturale direzione di flusso della falda. Il materiale costituente la barriera deve essere opportunamente selezionato in modo da avere la capacità bloccare all’interno della barriera l’inquinante, rimuovendolo dal flusso di falda. Configurazioni innovative di tale tecnologia sono rappresentate dalle barriere permeabili discontinue, costituite da una serie di pozzi passivi riempiti con materiale adsorbente, e dai dreni adsorbenti, costituiti da un sistema in grado di ridurre i tempi di bonifica grazie alla presenza di drenaggi. L’attività di ricerca è incentrata nella definizione dei parametri di progetto di barriere permeabili, sia continue che discontinue, che dei dreni, e nell’identificazione delle caratteristiche del materiale adsorbente. Il gruppo dispone della licenza d’uso del software COMSOL MultiphysicsTM.
Tecniche di rimozione di micro e macro-inquinanti da effluenti gassosi e di composti climalteranti – Micro and macro-pollutant removal techniques from gaseous effluents and flue gases: L’emissione in atmosfera di composti inquinanti è la principale causa del degrado della qualità dell’aria il cui deterioramento determina rischi per la salute dell’uomo e delle specie viventi. L’attività di ricerca si incentra sullo sviluppo di tecnologie innovative per la rimozione, direttamente alla sorgente, di micro e macro-inquinanti con particolare attenzione a i composti gassosi acidi, i micro inquinanti organici, le polveri inalabili ed i metalli pesanti parzialmente vaporizzabili. Il tema prevede, inoltre, una linea di ricerca finalizzata alla rimozione della CO2 sia dai gas di scarico che direttamente dall’atmosfera utilizzando approcci dell’ingegneria chimica e di processo e delle biotecnologie.
Tecnologie innovative per la produzione di combustibili rinnovabili – Innovative technologies for renewable fuel production: Il progressivo esaurimento delle riserve di combustibili fossili, nonché l’emissione in atmosfera di gas serra, ha rivolto l’attenzione della comunità scientifica verso tecnologie energetiche “pulite” e fonti energetiche alternative e rinnovabili. La produzione di biocombustibili e/o chemicals, sia in fase liquida, come ad esempio metanolo, dimetiletere e biodiesel, che in fase gassosa, come ad esempio biometano ed idrogeno, sta richiamando sempre più interesse scientifico. L’attività di ricerca è incentrata verso quelle tecnologie che permettono la produzione di tali combustibili, come gasificazione di matrici organiche con vapore, gassificazione di matrici organiche in acqua supercritica, digestione anaerobica pressurizzata, upgrading del biogas, reazioni catalizzate come water gas shift e methanation, lisi dell’acqua a bassa temperatura mediante sistemi energetici integrati catalizzati da fotocatalizzatori ovvero da sistemi elettrochimici, al fine di individuare i valori ottimali dei parametri che influenzano l’efficienza di tali processi.
Valorizzazione di biomasse e rifiuti organici per la produzione di composti pregiati – Biomass and organic waste valorization for valuable by-product production: L’attività di ricerca ha l’obiettivo di studiare la crescita microalgale mediante la realizzazione di fotobioreattori ad hoc, investigando i principali parametri di crescita ed il loro effetto sulla formazione di composti pregiati, quali, ad esempio, quelli per la cosmesi, la nutraceutica ed i cibi animali, o anche per la produzione di biocombustibili. Obiettivo aggiuntivo è quello di studiare la crescita microalgale come tecnica per il bio-sequestro e valorizzazione di correnti concentrate di CO2. L’attività di ricerca è focalizzata anche sullo studio di tecniche innovative per l’estrazione dei composti pregiati dalla biomassa microalgale. Inoltre, la ricerca prevede la valorizzazione di rifiuti organici e biomasse al fine di produrre composti quali biopolimeri, ovvero plastiche di natura biologica e biodegradabili in grado di sostituire le plastiche di origine fossile.
Analisi del rischio ambientale-sanitario – Environment-health risk analysis: La valutazione dell’impatto sulla salute dell’uomo e dell’ambiente causato da attività antropiche è un problema complesso che richiede la quantificazione dell’esposizione a composti chimici e la valutazione degli effetti che tali composti provocano sulla salute dell’uomo e dell’ecosistema. L’attività di ricerca è incentrata sulla valutazione quantitativa dell’esposizione che si determina, in uno o più punti, a seguito di uno scenario, anche complesso, di emissione. Il gruppo dispone della licenza d’uso del software CALL PUFFTM.
Tecniche avanzate di rilievo, monitoraggio, caratterizzazione e rappresentazione di aree urbane ed industriali – Survey, monitoring, characterization and depiction of urban and industrial areas: La descrizione accurata e precisa dello stato di fatto, diacronicamente monitorato in fieri, è il presupposto per una corretta gestione delle aree urbane e dei siti industriali. La costruzione “in digitale” e la fruizione immersiva degli spazi configurati e/o dei componenti rilevati, permetterà di integrare competenze e abilità interdisciplinari. Un quadro completo ed approfondito del sito di studio potrà essere ottenuto mediante tecniche di monitoraggio dei parametri ambientali e relative procedure di caratterizzazione. L’ambito di ricerca è dunque contraddistinto da un’attività sul campo cui seguiranno fasi di post-elaborazione dei dati acquisiti con l’impiego di tecniche di rilievo fotogrammetrico e modellazioni informative da utilizzare come basi per analisi tematiche e specialistiche.
Responsabile: Dino MUSMARRA
Partecipanti: Adriana ROSSI; Maria Laura MASTELLONE; Armando DI NARDO; Giovanni Francesco SANTONASTASO; Pasquale IOVINO; Stefano SALVESTRINI; Simeone CHIANESE; Amedeo LANCIA; Marina PRISCIANDARO; Evangelos Vasileios HRISTOFOROU; Alessandro ERTO; Mauro CAPOCELLI; Immacolata BORTONE; Antonio MOLINO; Karatza DESPINA (Assegnista); Angelo FENTI (Assegnista); Mohammad Saleh NAJAFINEJAD (Dottorando); Simona GALOPPO; Ilaria TOCCI; Mario LUISO; Raul MUNOZ; Cataldo DE BLASIO.
Integrated Mechanical Design - Progettazione Meccanica Integrata
Descrizione linee di ricerca: Competenza principale del gruppo di ricerca è l’impiego di ambienti simulativi integrati per la definizione simultanea delle caratteristiche di un prodotto e del relativo processo di fabbricazione e dismissione, prevedendo una spiccata interdisciplinarità ed un impiego sistematico della prototipazione virtuale che si serve della sperimentazione fisica per la corretta caratterizzazione e validazione dei modelli di simulazione. Molti dei vantaggi a lungo termine offerti dalla gestione integrata del ciclo di vita di un prodotto (PLM) non possono essere conseguiti senza una strategia complessiva di virtualizzazione e prototipazione, che preveda uno scambio continuo di informazioni tra la progettazione, la produzione e il disassemblaggio, anche in tempo reale. Nella sostanza, il gruppo di ricerca è in grado di effettuare la simulazione dei processi produttivi, fino a quelli manuali in ambiente di realtà virtuale immersiva, nonché delle conseguenti prestazioni del prodotto, con l’obbiettivo di ottimizzare i processi prima che i prodotti vengano fabbricati ed offrendo un feedback reciproco tra le diverse aree di competenza. Un tale approccio integrato alla progettazione favorisce la possibilità di validare in laboratorio (TRL4) tecniche e tecnologie innovative per lo sviluppo di un prodotto, nonché di dimostrale in ambienti industrialmente rilevanti (TRL5) grazie ai numerosi partner industriali con cui il gruppo di ricerca vanta collaborazioni più che decennali. Le attività del Gruppo di Ricerca sono sviluppate nell’ambito del Laboratorio di Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine del Dipartimento di Ingegneria.
Responsabile: Francesco CAPUTO
Partecipanti: Mario BUONO; Assunta CAPECE; Giuseppe LAMANNA; Roberto MACCHIAROLI; Marcello FERA; Donato PERFETTO; Salvatore GERBINO; Elena LAUDANTE; Giovanna GIUGLIANO; Mario CATERINO; Marta RINALDI; Monica LAMBERTI; Raffaele SEPE.
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Progetto e Costruzione di Macchine
Material Science and Engineering - Scienza ed Ingegneria dei Materiali
Descrizione linee di ricerca: Il gruppo si propone di continuare attività di ricerca nell’ambito della Scienza ed Ingegneria dei Materiali che riguardano gli overlapping con altri settori disciplinari in cui sono coinvolte le relazioni tra processi-proprietà-struttura dei sistemi materiali complessi, inclusi i materiali per uso biomedico, dalla scala nanometrica alla microscala a quella macroscopica delle strutture nei diversi settori civili ed industriali.
Area Scienza e Tecnologia dei Materiali
Meccanica dei materiali polimerici e compositi:
- Determinazione dei parametri delle leggi costitutive utilizzate dai codici agli elementi finiti mediante analisi di correlazione numerico sperimentale.
- Stress residui in materiali compositi a base polimerica.
- Modellazione dei fenomeni di fatica in strutture in materiale composito.
- Adesivi e Meccanismi di adesione.
Lo stato vetroso:
- Leggi costitutive per i tempi di rilassamento di polimeri nello stato vetroso.
- Attività Area Materiali.
Processing:
- Modellazione delle tecnologie di produzione di sistemi materiali compositi: sistemi reattivi e sistemi termoplastici per le applicazioni nei veicoli per il trasporto terrestre ed aerospaziale.
- Criteri di selezione e validazione di materiali strutturali e processi produttivi a basso costo.
- Compositi a matrice termoplastica: stati tensionali indotti dai processi di fusione/miscelazione/welding durante il processi di stratificazione nella realizzazione di strutture per applicazioni aerospaziali.
- Leggi costitutive per materiali compositi, polimerici e metallici sottoposti ad elevate velocità di deformazione tipiche di scenari d’impatto.
- Leggi costitutive per schiume polimeriche utilizzate come imbottiture dei sedili dei veicoli.
- Determinazione dei parametri delle leggi costitutive utilizzate dai codici agli elementi finiti mediante analisi di correlazione numerico sperimentale.
Area Costruzioni di Macchine
Analisi FEM di strutture in composito in campo automobilistico. Resistenza all’impatto. Ottimizzazione della risposta strutturale, ed adeguamento delle strutture in materiali innovativi alle richieste normative e di mercato.
Area Statistica e calcolo delle probabilità
Premesso che il settore si caratterizza per una specifica attenzione alle moderne problematiche statistiche sorte nell’ambito delle scienze sperimentali (statistica e calcolo delle probabilità, progettazione e analisi degli esperimenti) ed in particolare dell’ingegneria (affidabilità, controllo statistico di qualità) l’attività è essenzialmente incentrata sulle modellazione su base stocastica del degrado della resistenza dei materiali compositi e segnatamente sui fenomeni di fatica.
Area Automatica
L’attività prosegue a valle di un brevetto per sensore tattile nella modellazione di un materiale gommoso altamente non lineare e nella correlazione delle forze esterne ad esso applicate con le sue deformate, misurate con uno strato sensoriale optoelettronico innovativo basato su una matrice costituita da coppie phototransistor-LED (light-emitting diode).
Area Strutture Aerospaziali
Sviluppo di metodologie per la generazione rapida di strutture sottili 3D auto irrigidite libere da vincoli topologici. L’approccio è essenzialmente riferito a strutture in materiali composito e si presta a sviluppo di strutture su scala nanometrica.
Area Fisica
- Teorie dello stato vetroso per l’implementazione di modelli fenomenologici nella previsione delle proprietà tempo-dipendenti di materiali polimerici e compositi.
- Sviluppo di compositi filamentari su scala nanometrica per applicazioni,nel campo della giunzioni, nell’area della superconduttività.
- Proprietà meccaniche e tribologiche di mezzi granulari confinati. Applicazioni alla dinamica stick-slip.
Area Civile
- Criteri di validazione di armature innovative per applicazioni nel campo dell’ingegneria civile.
- Geo-materiali vetrosi e loro risposte tempo dipendenti: dinamiche eruttive effetti della pressione e della temperatura, nell’ambito del vulcanismo esplosivo.
- I vetri inorganici , equilibri oxi-redox.
Area Ingegneria Economico-Gestionale
Caratterizzazione meccanica di materiali di origine vegetale e possibili correlazioni con caratteristiche di trans-genicità.
Responsabile: Alberto D'AMORE
Partecipanti: Luigi GRASSIA; Michelina CATAURO; Claudio LEONE; Salvatore PIROZZI; Mauro SELLITTO; Giacomo ROTOLI; Roberto MORETTI; Luigi VERTUCCIO; Veronica VIOLA (dottoranda); Raffaele VERDE (dottorando); Zulfiqar ALI (dottorando); Saba YAQOO (dottorando); Pooyan PARNIAN (borsista)
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Scienze e Tecnologie dei Materiali
Measurement and Instrumentation - Misure e Strumentazione
Descrizione linee di ricerca: Il gruppo di Misure e Strumentazione ha maturato negli anni competenze specifiche nei settori della metrologia generale e dei metodi e sistemi di misura delle principali grandezze elettriche, elettroniche, termofluidodinamiche e meccaniche.
Le principali attività a carattere teorico-sperimentale sono:
- Metrologia generale (collaborazioni strutturate l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica INRIM e con UNI e CEI in materia di normativa tecnica metrologica).
- Metodi e sistemi di taratura delle principali grandezze elettriche, termiche e meccaniche.
- Progettazione, realizzazione e caratterizzazione di sistemi di misura.
- Analisi di problemi di qualità dell’alimentazione elettrica (Power Quality) e misurazioni di potenza e di energia anche in condizioni non sinusoidali.
- Sensori di misura per reti distributive a fluido (reti gas, reti acqua, reti teleriscaldamento/teleraffrescamento).
- Sistemi integrati di telecontrollo e supervisione (SCADA).
- Sistemi evoluti di telelettura (AMR:Automatic Meter Reading) di contatori d'utenza.
- Sistemi di misura e controllo per l’ottimazione dei consumi energetici nei sistemi industriali e di trasporto ferroviario.
- Progettazione, realizzazione e caratterizzazione di trasduttori di tensione e corrente della rete elettrica in regime non sinusoidale e dissimmetrico.
- Sensori evoluti (smart sensors) delle principali grandezze termiche e meccaniche.
- Contatori intelligenti (smart meter) per smart grid elettriche.
- Generazione e misura di Campi Elettrici Impulsivi (Pulsed Electric Fields, PEF) per applicazioni biomediche.
- Implementazione di un sistema innovativo wearable per la diagnosi precoce della sindrome di Brugada tramite misura dell’attività cardiaca.
Responsabile: Carmine LANDI
Partecipanti: Daniele GALLO, Mario LUISO; Antonio DELLE FEMINE, Gabriella CROTTI, Domenico GIORDANO, Davide SIGNORINO, Sara Letizia PALMA
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Misure Elettriche e Elettroniche, Laboratorio di Misure per l'e-mobility e gli smart energy system
Optoelectronic sensors - Sensori optoelettronici
Descrizione linee di ricerca:
Sensori distribuiti in fibra ottica
Il gruppo sviluppa sensori distribuiti di deformazione, temperatura e vibrazioni basati sullo scattering Brillouin e/o scattering Rayleigh, operanti sia nel dominio del tempo che nel dominio della frequenza. La possibilità di effettuare misure distribuite su distanze anche di diversi km consente di impiegare tali sensori per il monitoraggio di grandi strutture quali dighe, gallerie, ecc., Il gruppo ha dimostrato l’efficacia di tali sensori anche in ambiti legati al settore dei trasporti (monitoraggio del traffico ferroviario e del traffico stradale), a quello del monitoraggio ambientale (monitoraggio frane), nonché al settore aeronautico (monitoraggio di strutture in composito).
Sensori chimici e biochimici in fibra ottica
Questa linea di ricerca mira allo sviluppo di biosensori optoelettronici a basso costo e semplici da realizzare. Il principio della risonanza plasmonica di superficie (SPR) in fibra ottica, congiuntamente all'utilizzo di appositi recettori, è utilizzato per realizzare sensori ottici selettivi per applicazioni mediche e per la rivelazione di esplosivi, armi biologiche, droghe, inquinanti etc. nonché per il monitoraggio dell’olio dei trasformatori.
Responsabile: Aldo MINARDO
Partecipanti: Nunzio CENNAMO; Francesco ARCADIO; Chiara MARZANO; Ines TAVOLETTA; Luca Pasquale RENZULLO; Federica PASSEGGIO; Ernesto NAPPI; Fiore CAPASSO; Ester CATALANO; Agnese COSCETTA; Domenico DEL PRETE; Rosalba PITRUZZELLA; Riccardo ROVIDA; Stefano SPINA; Raffaele VALLIFUOCO; Luigi ZENI; Alessandro MEOLI.
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Optoelettronica, Laboratorio di Microscopia Elettronica
Power Electronics for Industry, Energy and Transport - Elettronica di Potenza per l'Industria, l'Energia ed i Trasporti
Descrizione linee di ricerca:
Il gruppo di ricerca ha come obiettivo quello di fornire supporto all’industria, ai gestori della rete elettrica di trasmissione e distribuzione ed al settore dei trasporti, progettando ed integrando (a bordo veicolo ed in rete), convertitori statici di potenza. Le competenze del gruppo sono multidisciplinari e vanno dalla progettazione di convertitori di potenza ad elevata densità di potenza, alla loro integrazione rispettando vincoli di Power Quality, alla modellazione ed al controllo. Per queste ragioni il gruppo ha forti interazioni con altri gruppi di ricerca dell’Ateneo.
Elettronica di Potenza per l'Industria
Il gruppo si è occupato di diversi temi con applicazioni nel settore industriale. Tra questi lo studio e lo sviluppo di convertitori statici di Energia Elettrica ad elevato rendimento, caratterizzati da una elevata Power Quality, con caratteristiche multifunzionali capaci di fornire servizi ancillari quali rifasamento dinamico, compensazione armonica e stabilizzazione della tensione. Particolare attenzione è stata rivolta ai convertitori multilivello ed alle loro tecniche di modulazione al fine di consentire un loro impiego in applicazioni in Media Tensione. In questo campo di ricerca si affronta anche lo studio e la fattibilità del trasformatore elettronico per applicazioni industriali mediante l'impiego combinato di strutture multilivello con convertitori risonanti. I prodotti di questa linea di ricerca consistono in prototipi realizzati in laboratorio, atti alla verifica sperimentale.
Elettronica di Potenza per l'Energia
Il gruppo si è occupato di diversi temi con applicazioni nel settore Energia. Tra questi lo studio e lo sviluppo di convertitori statici di Energia Elettrica ad elevato rendimento, per la connessione in rete della generazione da fonti rinnovabili. In particolare, sono stati studiati e sono in corso di realizzazione convertitori per l'interfaccia tra generatori elettrici da moto ondoso marino (incluso l’innovativo sistema di "power take-off") e rete di distribuzione, con caratteristiche multifunzionali capaci di fornire servizi ancillari quali rifasamento dinamico, compensazione armonica e stabilizzazione della tensione. Nel settore della bassa tensione, tipica dei sistemi fotovoltaici (con installazione a terra, mobile o galleggiante), vengono studiati convertitori risonanti ad altissima efficienza per il controllo de flussi energetici dei singoli pannelli e del loro sistema di gestione e supervisione, convertitori con componenti di nuova generazione (GaN e SiC) con elevate frequenze di commutazione e algoritmi di massima estrazione della potenza innovativi in termini di complessità, robustezza e numero di sensori utilizzati. Sono altresì studiati sistemi di conversione per generatori eolici e fotovoltaici di grande potenza per la connessione alla rete di alta tensione.
Elettronica di Potenza per i Trasporti
In questo settore il gruppo di ricerca si è occupato di diversi temi riguardanti il settore automotive, della trazione ferroviaria a livello treno al settore aeronautico. Le attività di ricerca sono relative alla realizzazione di convertitori soft-switching e risonanti ad elevata densità di potenza per applicazione a bordo veicolo, oppure per la ricarica ultraveloce di batterie. L’attività di ricerca comprende anche il controllo dei convertitori e la gestione dei flussi di energetici per l’ottimizzazione del sistema di trasporto in termini di peso e prestazioni. Ulteriori attività di ricerca nel settore aeronautico riguardano la realizzazione di sistemi di protezione a stato solido e Battery Management System per batterie agli ioni di Litio. Collaborazioni con importanti aziende nazionali e internazionali ed altri istituti di ricerca testimoniano l’impegno e la qualità degli studi svolti.
Responsabile: Luigi RUBINO
Partecipanti: Alfredo TESTA (Prof. Emerito); Alberto CAVALLO; Roberto LANGELLA; Pasquale CONTESTABILE; Alessandro LO SCHIAVO; Luigi COSTANZO; Muhammad AWAIS, Muhammad ISHAQ.
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Elettronica di Potenza, Laboratorio di Elettronica
Renewable Energies in Civil Engineering - Energie Rinnovabili nell’Ingegneria Civile
Descrizione linee di ricerca: Il gruppo di ricerca si pone l’obiettivo di dare una risposta concreta al problema della reciproca integrazione tra richiesta energetica e sostenibilità ambientale, promuovendo lo sviluppo di tecnologie innovative di produzione di energia da vento, moto ondoso, correnti fluviali e fonti geotermiche che si integrino con le infrastrutture civili interagenti. Il gruppo opera fattivamente sulla ricerca e sviluppo di sistemi innovativi basati sullo sfruttamento delle fonti energetiche rappresentate dalle risorse naturali marine, eoliche e geotermiche ed idrauliche. In tale contesto si innestano, ad esempio, i progetti legati allo sviluppo del sistema DIMEMO e di MaRELab. Il sistema DIMEMO propone un diverso approccio nella progettazione delle dighe marittime, con l’obiettivo di catturare e sfruttare l’energia prodotta dal moto ondoso anziché dissiparla. Il laboratorio in mare aperto MaRELab, invece, rappresenta il luogo di sperimentazione di nuove tecnologie rinnovabili “blu”, tra cui turbine eoliche galleggianti o turbine idroelettrica a micro-prevalenza. Alcuni componenti del gruppo, altresì, studiano i meccanismi di funzionamento delle fondazioni geotermiche. Si tratta di elementi caratterizzati dalla presenza di pali di fondazione che consentono l’estrazione di energia geotermica grazie allo scambio di calore tra terreno e pali. In virtù della forte attinenza, il gruppo collabora con altri gruppi di ricerca di Dipartimento.
Responsabile: Diego VICINANZA
Partecipanti: Pasquale CONTESTABILE; Michele IERVOLINO; Corrado GISONNI; Gaetano CRISPINO; Antonio PANICO; Alessandro MANDOLINI; Massimiliano FERRAIOLI; Luigi MOLLO; Mario BUONO; Roberto MORETTI; Luigi RUBINO; Andrea UNICH; Antonio MARIANI; Sara GONIZZI BARSANTI; Chiara IODICE; Bernardo BUONOMO; Oronzio MANCA; Sergio NARDINI; Caterina ERAMO; Stefania DI RONZA.
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Idraulica - Idraulica Marittima e MaRELab, Laboratorio di Sistemi Elettrici (SUN-EMC-LAB)
Resources Recovery & Reuse (Rcube) - Recupero e Riuso di Risorse (R_al_cubo)
Descrizione linee di ricerca:
Digestione anaerobica di biomasse residuali. Sono indagati i processi di produzione di bioidrogeno e biometano da fermentazione anaerobica in condizioni dark di biomasse residuali con elevato tenore di umidità. In tale ottica, l’ottimizzazione del processo di fermentazione anaerobica viene realizzato tramite valutazione dei principali parametri del processo e dei pretrattramenti. Viene indagato l’effetto dell’utilizzo di inoculo di percolato oppure di sostanza solida (HC) proveniente dal processo di Carbonizzazione Idrotermale (HTC). Inoltre, viene indagato il recupero di materia dallo stesso processo, quale la produzione di acido lattico e altri acidi ad altro valore economico aggiunto. Nell’ambito dell’attività sono effettuate caratterizzazioni delle popolazioni microbiche attraverso test biomolecolari (DGGE) sul substrato per ottenere un quadro completo della dinamica delle comunità microbiche presenti nel substrato durante il processo di fermentazione anaerobica.
Utilizzo di miscele idrogeno/metano: l’utilizzo e l’applicazione delle miscele e il loro relativo impatto ambientale è indagato attraverso prove sui motori a combustione interna. Tali indagini hanno quantificato riduzioni di anidride carbonica e inquinanti gassosi come CO, NOx, e particolato. È stato progettato e realizzato, con l’azienda ECOS srl, un miscelatore idrogeno‐metano per l'alimentazione dei veicoli sottoposti a prove di laboratorio.
Processo di Carbonizzazione Idrotermale (HTC). Le attività relative al processo di carbonizzazione idrotermale (HTC) sono realizzate in una scala da banco del volume di 3000 ml e in un impianto pilota da 100 litri. Un parametro cruciale che influisce sulla sostenibilità economica del processo HTC è il liquido (acqua) utilizzato: rapporto liquido/rifiuti organici, tipo di liquido, tasso di riciclo del liquido nel processo sono variabili che influenzano lo scaling industriale sia dal punto di vista tecnologico che motivo economico. L'acqua di diluizione, che rappresenta il mezzo di reazione per HTC, verrà fatta ricircolare per una serie di altri cicli. In questo modo, il costo per lo smaltimento del liquido di scarico dopo il completamento del processo HTC sarà ridotto al minimo. La possibilità di applicare l'HTC al digestato influisce sul modo tradizionale della sua gestione. Il digestato, infatti, viene normalmente destinato al compostaggio o immesso direttamente nel terreno senza mineralizzazione. In quest'ultimo caso si verifica una proliferazione di batteri sul suolo in quanto l'indice di respirazione del digestato è elevato e le proprietà del suolo non vengono modificate positivamente ma, al contrario, vengono impoverite.
Analisi energetica, economica e ambientale di sistemi energetici alternativi. È sviluppato un modello per la determinazione delle emissioni di gas serra da parte delle aziende zootecniche per la produzione di idrogeno e metano da biomasse e per valutare la convenienza tecnico–economica di impianti di digestione per la produzione dei biogas di dimensioni medio/grandi per siffatta tipologia di aziende. Inoltre, sono condotte analisi energetiche ed exergetiche di cicli Organici Rankine ORC per il recupero termico da impianti di conversione dell’energia e utilizzo di sistemi a pompe geotermiche per il condizionamento ambientale per la valutazione delle efficienze e dell’impatto economico dei sistemi.
Studio innovativo di produzione sostenibile di biomassa vegetale. È svolto lo studio di piante, principalmente di macchia mediterranea, resistenti alla siccità ed alla salinità, utilizzabili per la produzione di principi attivi di interesse farmaceutico e/o nutraceutico e il successivo utilizzo degli scarti organici per la produzione di biogas.
Recupero della risorsa idrica dai reflui zootecnici. Le acque reflue, e i reflui zootecnici in particolare, possono e devono essere inquadrati come una preziosa risorsa idrica non convenzionale, da destinare a usi multipli. Un refluo depurato da un tradizionale impianto di trattamento può risultare idoneo al riutilizzo solo dopo un potenziamento delle fasi volte alla riduzione dei tenori di organico (BOD5) e del contenuto di solidi oltre che all’abbattimento della carica microbica. A tal proposito verranno studiate e messe a punto soluzioni innovative, opportunamente sviluppate per ogni singolo caso specifico, basate su una fase biologica ibrida, a colture sospese/adese, del tipo MBBR (Moving Bed Bio-Reactor), oppure facendo ricorso a reattori biologici a membrane (MBR, Membrane Bio-Reactor), a filtri biologici aerati, a letto fisso (BAF, Bio-Aerated Filter e SAF, Submerged Aerated Filter) o a letto mobile (FBR, Fluidized Bed Reactor). All’occorrenza i processi biologici verranno integrati con fasi di affinamento del trattamento mediante processi chimico-fisici.
Lombricompostaggio per deiezioni bufaline. L’obiettivo è adattare le tecniche e le modalità di gestione del processo di lombricompostaggio alle esigenze dell’allevatore bufalino, trasformando la gestione del letame bufalino da problema per l’allevatore ad opportunità che elimina il rischio di inquinamento da nitrati generando al contempo una significativa redditività. I lombrichi individuati sono in grado di stabilizzare il letame, giunto alla fine della fase termofila della fermentazione, trasformandolo in 6-12 ore in vermicompost, ammendante che ha macro e micro elementi in forma inorganica, presenza di ormoni per la crescita (in particolare auxine e gibberelline), di antipatogeni, significativa presenza di acidi umici e fulvici e per avere una carica microbica fino a mille volte superiore rispetto alla matrice iniziale.
Nanofilm di carbonio prodotti in fiamma. La formazione di particelle carboniose in processi di combustione ha un impatto negativo sulla salute e sull'ambiente, ma queste stesse particelle possono essere convenientemente sfruttate per la produzione, in fiamma, di “smart materials” utili in svariati ambiti come: celle solari, diodi emettitori di luce, biological labelling, sensori e ricoprimenti superidrofobici. Le proprietà delle particelle carboniose possono essere finemente modificate agendo sulle condizioni del processo di combustione (ad es. temperatura di fiamma, combustibile usato, tipo di combustore).
Responsabile: Biagio MORRONE
Partecipanti: Andrea UNICH; Antonio MARIANI; Antonio PANICO; Mario MINALE; Claudia CAROTENUTO; Domenico DE FALCO; Petronia CARILLO; Maria Laura MASTELLONE; Lucio ZACCARIELLO; Stefania PAPA ; Pasqualina WOODROW ; Annalinda CAPONE; Saif SERAG; Raffaella GRIFFO; Rosada ESPOSITO.
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Biofermentazioni; Laboratorio di Reologia
Reverse Engineering and Design for AM - Ingegneria Inversa e Progettazione per la Stampa 3D (RE&DfAM)
Descrizione linee di ricerca: Il gruppo di ricerca ha competenze specializzate nell'utilizzo di strumenti hardware (HW) e ambienti software (SW), anche personalizzati, per i processi di Reverse Engineering (RE), e per la progettazione e produzione di componenti e sistemi meccanici utilizzando l'approccio Design for Additive Manufacturing (DfAM). Il RE comprende una serie di processi, come la scansione 3D, la manipolazione dei dati acquisiti e la ricostruzione CAD fedele degli oggetti reali. Per mezzo delle scansioni effettuate con sistemi ottici e la fotogrammetria (anche integrata con i primi), il gruppo di ricerca è in grado di ricostruire i modelli virtuali degli oggetti reali di varie dimensioni, anche nell’ottica Digital Twin. Inoltre, vengono effettuati controlli di qualità attraverso operazioni di ispezione locale e globale, utilizzando come riferimento il modello CAD nominale. Questo processi, eseguiti anche con l’implementazione di codici SW ad hoc, consentono di potenziare i processi di re-design e di effettuare un controllo sulla qualità del processo di fabbricazione, calcolando le tolleranze di lavorazione su specifiche caratteristiche geometriche. Il RE ben si integra con la tecnologia AM grazie al quale si possono velocemente realizzare i modelli 3D ricostruiti oltre che produrre parti di ricambio, componenti finali e supporti in ottica DfAM.
Responsabile: Salvatore Gerbino
Partecipanti: Alessandro GRECO; Giuseppe LAMANNA; Alessandro DE LUCA; Elena LAUDANTE; Pasquale MANCO; Massimo MARTORELLI.
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Progetto e Costruzione di Macchine
Robotics and Mechatronics - Robotica e Meccatronica
Descrizione linee di ricerca:
Robotica. Il gruppo si occupa di diversi temi con applicazioni sia nel settore dei servizi che nel settore industriale. Il primo riguarda lo sviluppo di tecnologie sensoriali e di attuazione per grasping e manipolazione destra. Su questo tema sono stati sviluppati algoritmi di slipping detection and avoidance oltre che di manipolazione in-hand tramite gripper paralleli equipaggiati con sensori di tatto brevettati dal gruppo di ricerca. Il secondo tema è focalizzato sulla manipolazione di oggetti deformabili tramite sistemi di presa sensorizzati e modulari. Le applicazioni di queste tecnologie sono soprattutto nella robotica di servizio e la logistica. Il terzo tema riguarda la robotica collaborativa e vede il gruppo di robotica e meccatronica impegnato nello studio di metodi di monitoraggio dello spazio di lavoro tramite sistemi di percezione multimodale e nella progettazione di sistemi di controllo della velocità dei robot, basati su tecniche di intelligenza artificiale, per minimizzare i rischi per gli operatori umani che condividono con essi lo spazio di lavoro o il compito. Le applicazioni di robotica nel settore industriale che vedono il gruppo coinvolto in progetti di ricerca in collaborazione con aziende manifatturiere riguardano tecniche di assemblaggio automatizzato di fusoliere aeronautiche tramite celle multi-robot.
Meccatronica. Il gruppo è impegnato nello sviluppo di algoritmi di controllo predittivo per veicoli connessi e automatici nell’ambito del progetto C-Mobility della piattaforma regionale di mobilità sostenibile Borgo 4.0. L’obiettivo principale è la progettazione e realizzazione di sistemi abilitanti le connessioni tra veicoli (connessioni V2V), tra veicoli ed infrastruttura stradale (connessioni V2I) e tra veicoli ed altri soggetti esterni (genericamente V2X), allo scopo di rendere possibile l’implementazione di innovative applicazioni di sicurezza attiva di tipo cooperativo, e l’erogazione di servizi avanzati al veicolo. Il gruppo di ricerca è impegnato nella progettazione di sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), quali adaptive cruise control, lane keeping system e sistemi di monitoraggio del conducente tramite tecniche di intelligenza artificiale.
Responsabile: Ciro NATALE
Partecipanti: Alberto CAVALLO; Salvatore PIROZZI; Antonio RUSSO; Marco COSTANZO; Gianluca LAUDANTE; Ahamad FAZAL TANZEEL (dottorando); Marco DE SIMONE (dottorando), Sara FEDERICO (dottoranda); Michele MIRTO (dottorando), Olga PENNACCHIO (dottaranda); Sajjad Miralizadeh Jalalat (dottorando); Francesco Tucci (dottorando); Raffaele Mazza (dottorando)
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Automatica, Laboratorio di Robotica
Safety and Reliability of Vehicles - Sicurezza e Affidabilità dei veicoli
Descrizione linee di ricerca: Il gruppo di ricerca intende proseguire nella pluriennale attività di studio del comportamento delle strutture dei veicoli nell’ambito della mobilità automobilistica, aeronautica, ferroviaria e agricola. Il gruppo di ricerca è specializzato nell’analisi, modellazione, progettazione, costruzione e caratterizzazione sperimentale di strutture tradizionali e ibride costituite da parti in materiali di diversa tipologia e annesse metodologie di giunzione strutturale oltre a strutture e componenti realizzati mediante tecnologie di Additive Manufacturing. L’attività di progettazione include lo studio di soluzioni architetturali innovative, di soluzioni ibride e multimateriale, di soluzioni compatibili con i concetti dell’economia circolare. Sono inclusi i componenti ed i dispositivi a bordo vettura quali ad esempio quelli dedicati alla sicurezza degli occupanti. Particolare attenzione è rivolta alle analisi biomeccaniche per studiare gli effetti degli impatti sul corpo umano valutati secondo i più avanzati indici di danno, nonché con il danneggiamento progressivo delle strutture, in relazione ai requisiti richiesti dalla damage tolerance. Ai metodi tradizionali della progettazione meccanica sono affiancate tecniche e metodologie di ottimizzazione, nelle sue diverse declinazioni, mediante l’utilizzo critico di codici numerici. Specialmente nel caso di utilizzo di materiali compositi e/o prodotti con tecnologie additive. L’attività sperimentale, si basa sulle competenze di meccanica sperimentale del gruppo, e include varie tipologie di prove quasi-statiche, dinamiche, di impatto, di creep, volte alla caratterizzazione dei materiali di interesse e alla valutazione della risposta strutturale di componenti soggetti a carichi diversi.
Responsabile: Giuseppe LAMANNA
Partecipanti: Francesco CAPUTO; Alessandro DE LUCA; Salvatore GERBINO; Alessandro GRECO; Mariano PERNETTI; Donato PERFETTO (assegnista); Giovanna GIUGLIANO (assegnista); Enrico ARMENTANI.
SFS.DEMON: Solid Fluid & Structure Design Modeling and Numerical analysis - Solidi, Fluidi e Strutture - Progettazione, Modellistica e Calcolo Numerico
Descrizione linee di ricerca:
Applicazione del metodo degli elementi finiti e del metodo degli elementi al contorno nell'analisi fluidodinamica e strutturale. Viene sviluppato l'elemento finito lineare e non lineare fondamentale per il comportamento strutturale nella struttura dell'elasticità, l'iperelasticità, la plasticità e l'analisi limite. Le equazioni di base sono state implementate in codici computazionali fatti da sé incentrati sulla formulazione della dinamica strutturale non lineare, della plasticità e del calcolo del collasso. Inoltre, è stata studiata l'interazione fluido-struttura riguardante gli effetti della deformazione del canale rispetto al flusso del fluido in un sistema di raffreddamento di motori a razzo. Il codice commerciale Ansys FEM viene utilizzato attraverso il linguaggio di programmazione Ansys nativo APDL, formulando codici ad hoc che simulano il flusso di fluidi in mezzi porosi e gli effetti del verificarsi di sforzi-deformazioni sull'evoluzione dei fluidi. Il primo, vale a dire i fondamenti del calcolo scientifico discreto, è trattato dal punto di vista dei metodi variazionali meccanici. I risultati dell'approccio di base sono dettagliati su diversi aspetti di applicazioni e casi pratici. Oltre agli elementi finiti, viene implementato anche il metodo degli elementi al contorno per risolvere l'elasticità eterogenea e la meccanica della frattura. In particolare, per considerare l'eterogeneità del materiale è stato derivato un metodo misto campo-elemento al contorno, FBEM. Le equazioni integrali al contorno del campo sono state risolte utilizzando tecniche di collocazione e integrazione. Lo stress interno è stato calcolato utilizzando le funzioni di forma degli elementi di campo per evitare l'integrazione complessa di nuclei di deformazione ipersingolari derivanti da FBEM eterogenei.
Comportamento limite delle strutture. L'attività di ricerca indaga il collasso e il limite delle strutture utilizzando la teoria della plasticità e metodi di instabilità. L'analisi limite è implementata nel codice FEM e FBEM definendo lo spazio di autostress. L'autostress è la distribuzione delle sollecitazioni di una struttura corrispondente a carichi nulli. È l'intervallo della soluzione autoequilibrata delle equazioni di equilibrio e rappresenta la molteplicità dello stato di sollecitazione all'equilibrio di una struttura e di un solido. L'autostress è l'aspetto cruciale dell'analisi del collasso all'interno della teoria della plasticità standard. Tuttavia, anche quando la plasticità non standard è il modello costitutivo della struttura reale in esame, la teoria di Radenkowic consente di utilizzare l'approccio standard a una struttura fittizia realizzata con materiale standard. Fornisce il limite superiore e inferiore del carico di collasso effettivo, anche se l'intervallo limite superiore-inferiore non svanisce, a condizione che il materiale non sia standard. Diverse applicazioni delle teorie dello stato limite delle strutture sono state applicate a casi strutturali esemplificativi, ad esempio: crollo di edifici, cupole, volte e ponti, comportamento di instabilità di assiemi di piastre sotto carichi assiali e misti.
Sistemi di monitoraggio strutturale con sensori innovativi. Sensori innovativi basati sulla diffusione Brillouin in fibre ottiche sono stati sviluppati e utilizzati per il monitoraggio di strutture e pendii. Il sensore è progettato per interagire con gli inclinometri quando viene utilizzato per monitorare frane e pendii in movimento. Inoltre, il sensore è dotato di un sistema di rinforzo che origina un trasduttore strutturale combinato che svolge il ruolo di rinforzo intelligente che, oltre all'effetto di miglioramento strutturale, rappresenta anche il modo per acquisire in tempo reale l'evoluzione delle deformazioni nelle strutture. Il modo in cui agisce il sensore costituisce un rinforzo intelligente e un sistema di preallarme per verificare l'efficacia del rinforzo durante la vita strutturale.
Valutazione della sicurezza strutturale alla scala territoriale, di comparto urbano e di singola unità edilizia. Per aumentare la resilienza e la capacità di valutare e gestire gli effetti dei disastri, le autorità pubbliche e private e la gestione del territorio dovrebbero essere dotate di una conoscenza dettagliata delle criticità degli insediamenti e di strumenti pratici e rapidi per prevedere le aree e le situazioni in cui affrontare il primo soccorso e verso il quale dedicare gli sforzi successivi per risolvere i problemi emergenti. La sicurezza strutturale è uno degli aspetti significativi che devono essere affrontati. In particolare, devono essere predisposte strategie e procedure rapide ed efficaci che costituiscano un quadro di riferimento per l'organizzazione e la progettazione dell'attività. La proposta mira a definire un sistema di classificazione e mappare il rischio relativo a disastri naturali come terremoti, frane e colate detritiche. Per impostare una procedura e un protocollo normativo, le strutture devono essere classificate in base alle loro caratteristiche geometriche e meccaniche, differenziandole in sottoinsiemi di morfotipo con simili macrocaratteristiche. Le mappe locali evidenziano zone uniformi con morfologia di strutture simili, definendo micro o macroaree di pari vulnerabilità. Le analisi vengono eseguite attraverso un push-over semplificato attraverso l'approccio di Melan per limitare l'analisi eseguita con una procedura robusta basata su un elemento finito discontinuo già testato per casi simili. Una strategia di classificazione viene impostata attraverso l'elaborazione dei dati dei risultati ottenuti utilizzando il parametro principale dell'insieme di funzioni che definiscono la curva di capacità per ciascun morfotipo. I risultati sono implementati in abachi di facile utilizzo, rappresentazione GIS e mappe tematiche del rischio. I risultati completi costituiscono proposte per la gestione e la mitigazione degli effetti dei disastri naturali e artificiali.
Meccanica dei materiali porosi e interazione solido-fluido. Nel presente tema di ricerca, presentiamo un modello poroelastico lineare per una trave a doppio strato oscillante quasi statica costituita da due strati spessi in perfetto legame alla loro interfaccia, caratterizzati da diversi moduli elastici e permeabilità, entrambi direttamente influenzati dalla porosità. La soluzione è costruita considerando la struttura come un oggetto tridimensionale. Si ottiene analiticamente per l'accoppiamento completo del bilancio di massa e delle equazioni meccaniche imponendo condizioni al contorno deboli sulle sole forze che emergono alle superfici laterali più esterne, trascurando gli effetti inerziali. Dopo aver verificato l'accuratezza della soluzione confrontando i risultati teorici e i risultati numerici delle simulazioni agli elementi finiti, sono state quindi eseguite analisi di sensitività ad hoc per indagare gli effetti sulla distribuzione delle sollecitazioni e sul flusso del fluido dovuti a prescritte disomogeneità legate alle variazioni dei parametri materiali e geometrici lungo lo spessore della trave, mantenendo costante il volume totale dello scheletro solido poroso e applicando forze assiali e momenti flettenti autoequilibrati e oscillanti nel tempo su due lati opposti della struttura. Sono state inoltre eseguite alcune analisi dinamiche per evidenziare i periodi e gli intervalli di frequenza appropriati in cui i carichi impulsivi assicuravano la risposta quasi statica del sistema, discutendo tuttavia le interferenze dovute ai regimi transitori per casi selezionati sulla base di analisi numeriche. Infine, mostriamo che, giocando con i rapporti tra moduli elastici, spessore e porosità dei due strati, è possibile osservare una serie di comportamenti controintuitivi o addirittura non convenzionali, che danno luogo a fenomeni di riflusso inaspettati e distribuzioni anomale del contenuto di fluido , nonché per stressare i picchi generati dallo spostamento dell'interfaccia dello strato e dall'irrigidimento complessivo che potrebbero essere tutti sfruttati per la progettazione di nuovi metamateriali poroelastici multi-obiettivo.
Rimodellamento osseo. L'osso è uno straordinario materiale biologico che adatta continuamente la sua microstruttura gerarchica per rispondere a carichi statici e dinamici per offrire caratteristiche meccaniche ottimali, in termini di rigidità e tenacità, su diverse scale, dai costituenti sub-microscopici all'interno degli osteoni, dove l'attività ciclica di osteoblasti, osteoclasti e osteociti ridisegna forma e percentuale di cristalli minerali e fibre collagene fino al livello macroscopico, con processi di accrescimento e rimodellamento che modificano l'architettura dei distretti ossei sia compatti che porosi. Nonostante la complessità intrinseca della meccanobiologia ossea, che comporta fenomeni di accoppiamento di micro-danneggiamento, apporto di nutrienti guidato dal fluido che scorre attraverso reti gerarchiche e turnover cellulare, in letteratura sono stati presentati modelli di successo e algoritmi numerici per prevedere, su macroscala, come rimodellamento osseo sotto stimoli meccanici, aspetto fondamentale in molte applicazioni mediche come l'ottimizzazione delle protesi femorali e la diagnosi del rischio frattura. In questo quadro, una delle strategie più classiche impiegate negli studi è la cosiddetta legge di Stanford, che consente di caricare l'effetto dello stimolo di stress indotto dal carico dipendente dal tempo in un modello biomeccanico per indovinare l'evoluzione della struttura ossea. Nel presente lavoro, generalizziamo questo approccio introducendo la poroelasticità ossea, incorporando così nel modello il ruolo del contenuto fluido che, guidando i nutrienti e contribuendo alla rimozione dei rifiuti delle cellule del tessuto osseo, interagisce sinergicamente con i classici campi di stress per modifica gli stati di omeostasi, le condizioni di saturazione locale e riorienta il tasso di densità ossea, influenzando in questo modo la crescita e il rimodellamento.
Meccanica ossea e modelli e calcoli degli impianti. L'artroplastica totale dell'anca è stata una delle procedure chirurgiche di maggior successo in termini di risultati e soddisfazione del paziente. Tuttavia, a causa dell'aumento dell'aspettativa di vita e della relativa incidenza di malattie ossee età-dipendenti, un numero crescente di casi di fratture intraoperatorie porta a interventi di revisione con alti tassi di morbilità e mortalità. I chirurghi scelgono il tipo di impianto, protesi cementata o non cementata, in base all'età, alla qualità dell'osso e alle condizioni mediche generali del paziente. Generalmente non sono disponibili misure quantitative per valutare il rischio di frattura intraoperatoria. Di conseguenza, il processo decisionale si basa principalmente sull'esperienza degli operatori chirurgici e sulle informazioni qualitative ottenute dall'imaging. Motivati da questo scenario, proponiamo una strategia meccanica a supporto per assistere i chirurghi nelle loro decisioni fornendo mappe comprensibili del rischio di frattura, che considerano l'interazione tra l'effettiva distribuzione della forza meccanica all'interno del tessuto osseo e la sua risposta alle forze esercitate dall'impianto.
Responsabile: Vincenzo MINUTOLO
Partecipanti: Eugenio RUOCCO; Lucio OLIVARES; Emilia DAMIANO; Luca ESPOSITO; Giorgio RICCARDI; Andrea VACCA ; Andres SAEZ PEREZ; Paolo GARGIULO; Renato ZONA; Simone PALLADINO; Habib HIMANI; Lorena GUERRINI; Sehrish BIBI; Caterina ERAMO; Stefania DI RONZA.
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Strutture Civili
Smart and Safe Cities: sustainable design and innovative technologies for urban regeneration - Città smart e sicure: progettazione sostenibile e tecnologie innovative per la rigenerazione urbana
Descrizione linee di ricerca: Il gruppo di ricerca articola le proprie attività secondo varie linee di ricerca, con l’obiettivo comune di sviluppare il concetto dell’ottimizzazione del sistema urbano, con riferimento sia alla salvaguardia dell’ambiente naturale che alla sicurezza del centro abitato. In particolare, le principali linee caratterizzanti gli interessi di ricerca del gruppo sono:
Gestione sostenibile del sistema delle acque in ambiente urbano
Le variazioni del clima e del paesaggio contemporaneo, determinano spesso nefasti fenomeni di allagamento e collasso delle infrastrutture dedicate; peraltro, tali infrastrutture risultano sovente sottodimensionate, progettate sulla base di criteri ormai obsoleti, o non adeguatamente manutenute. La ricerca sulle metodologie per la gestione sostenibile delle sistema delle acque urbane, intende rispondere alle esigenze di sicurezza, efficienza e salvaguardia (qualitativa e quantitativa) delle risorse attraverso strumenti di controllo e gestione intelligente dei sistemi idrici e delle aree fluviali e costiere. Buone pratiche sono: la massimizzazione di aree verdi e superfici permeabili; la protezione delle falde; l’eventuale riuso delle acque meteoriche e reflue depurate; la decentralizzazione dei sistemi depurativi; la riqualificazione eco-sostenibile dei corsi d’acqua e delle aree costiere. Il gruppo si avvale della modellazione numerica e della sperimentazione su modello fisico per la simulazione del comportamento idraulico delle infrastrutture e dei loro principali componenti. In maniera sinergica, verrà studiato il potenziamento di tecniche e tecnologie fondate su principi naturali, al fine di dare luogo a paesaggi di notevole qualità percettiva ed ecologica che coniughino le esigenza della sicurezza dei centri abitati con la esigenza di ridurre i fenomeni di inquinamento.
Design ed infrastrutture
Il Design si inserisce nell’ambito della tematica Smart City a supporto di una pianificazione urbana “intelligente” per lo sviluppo di obiettivi specifici tecnico-socio-culturali ed economici. In tal senso, lo scopo principale è introdurre un nuovo, indipendente approccio strategico per la progettazione, la costruzione e la “messa in rete”, tenendo conto di leggi e regolamenti da unire e completare onde ottenere il necessario impulso per una riformulazione delle norme vigenti in materia di contenimento e ottimizzazione dei consumi energetici. Attraverso l’analisi di aree omogenee di intervento per tipologie edilizie e urbanistiche, destinazioni d’uso e funzione delle caratteristiche quali-quantitative e fisico-ambientali sarà possibile profilare degli scenari che consentano di sviluppare, gestire, monitorare e controllare le reti di distribuzione, incentivare e diffondere sistemi per la mobilità sostenibile privata e urbana attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative specifiche e armoniosamente integrate nel costruito per l’approvvigionamento e la distribuzione intelligente dell’energia.
Architecture and Building Technologies
Questa linea di ricerca si interessa degli aspetti costruttivi dell'edilizia - materiali, elementi, componenti, sistemi e processi - e delle loro implicazioni nella definizione del progetto di architettura e nella trasformazione sostenibile dell'ambiente naturale e costruito. Questa linea si avvale anche del Laboratory of Architecture and Building Technologies (LABTech). L’attività di ricerca, teorica e sperimentale, è riconducibile, principalmente, ai seguenti argomenti: tipologie edilizie, studio dei sistemi costruttivi anche con attività di sperimentazione in laboratorio, metodologie innovative (BIM, AR e VR) nella progettazione tecnologica degli edifici, edilizia circolare anche con riferimento alle prestazioni energetiche ed ambientali degli edifici valutate in relazione alle loro caratteristiche costruttive.
Urban and Regional Eco-Planning
La dimensione ambientale, nella pianificazione territoriale e urbana e nelle discipline del progetto di territorio, ha evidenziato alcune contraddizioni di fondo, ha posto in discussione alcune acquisizioni disciplinari che supportavano la teoria e la prassi negli ultimi decenni e ha imposto una revisione critica e/o una rifondazione di alcuni assiomi, considerando i cambiamenti naturali in atto a scala regionale e globale e gli effetti associati delle varie forme di pericolosità -naturale e non-su un’ambiente metropolitano sempre più vulnerabile e attrattore di rischio. L’attività di ricerca, teorica e sperimentale, del gruppo si svolge anche attraverso la consulenza ad alcuni enti territoriali che costituiscono il vero laboratorio per le discipline del territorio e che offrono la possibilità di una sperimentazione finalizzata ad aggiornare e/o rifondare alcuni riferimenti essenziali al processo di pianificazione e progettazione del territorio. In questo quadro scientifico si collocano alcune attività di ricerca riferibili in modo più specifico alle seguenti problematiche: antropizzazione dilagante del territorio, abusivismo edilizio, consumo di suolo, gestione sostenibile delle acque in ambiente antropizzato, aree produttive ecologicamente compatibili, rischi naturali, in particolare geologici.
Mobilità sostenibile
Il settore dei trasporti incide per oltre un terzo su consumi energetici, emissioni inquinanti e gas serra. Lo sviluppo di metodi e modelli innovativi ed efficaci per una pianificazione, programmazione e progettazione sostenibile della mobilità e dei trasporti è fondamentale. I ricercatori afferenti al S.S.D. ICAR/05 svolgono da anni ricerca ad alto impatto internazionale e nazionale (es. nel 2% dei migliori ricercatori mondiali nella categoria “Logistics & Transportation” secondo la classifica dalla Stanford University; punteggio massimo nelle ultime valutazioni della Qualità della Ricerca VQR) su tematiche che includono: processi decisionali per la pianificazione dei sistemi di trasporti; metodi e procedure per la redazione di piani di investimento; modelli e metodi per la stima dell’offerta, della domanda di mobilità e dell’assegnazione alle reti di trasporto; modelli e metodi per la simulazione dei terminali di trasporto delle merci e dei passeggeri; modelli e metodi per la stima degli impatti degli interventi sui sistemi di trasporto (es. costo generalizzato di trasporto, emissioni ed inquinamento, accessibilità, qualità nel trasporto, equità, resilienza); metodi di valutazione degli investimenti (es. analisi costi benefici e multicriteriali). Il gruppo di ricerca dispone del Laboratorio di Sistemi di Trasporto con attrezzature all’avanguardia tra cui: contatori di flussi veicolari; strumenti di misura delle emissioni prodotte dai veicoli; software specialistici.
Responsabile: Corrado GISONNI
Partecipanti: Mario BUONO; Assunta CAPECE; Armando CARTENÌ; Pasquale CONTESTABILE; Gaetano CRISPINO; Armando DI NARDO; Roberto GRECO; Michele IERVOLINO; Elena LAUDANTE; Salvatore LOSCO; Luigi MOLLO; Erica ORSI; Renata VALENTE; Diego VICINANZA
Laboratorio di riferimento: Laboratory of Architecture and Building Technologies (LABTech), Laboratorio di Idraulica e Idraulica Marittima
Smart Materials Science: Hybrid, Nano-Composites & Geopolymers - Scienza dei Materiali Intelligenti: Ibridi, Nano-Compositi e Geopolimeri
Descrizione linee di ricerca: L’attività di ricerca verte principalmente sulle tematiche relative al SSD CHIM/07 con particolare riferimento a tematiche interdisciplinari legate al campo della chimica impiegata per lo sviluppo di nuovi materiali e loro trattamento e coinvolge competenze di altri SSD principalmente per la parte di modellazione e simulazione dei processi di trasformazione (ING-IND/24). In particolare, l’attività di ricerca si focalizza sulla sintesi e progettazione di materiali ibridi organici-inorganici nanocompositi, da applicare in differenti aree di applicazioni che vanno dall’elettronica, alle costruzioni, alla medicina fino all’aeronautica.
I principali interessi scientifici dei partecipanti al gruppo riguardano le linee di ricerca:
- Progettazione e Sviluppo di compositi polimerici intelligenti (materiali termoindurenti e termoplastici autogeneranti aventi integrata la funzione del controllo autonomo del danno; compositi strutturali multifunzionali; materiali “self-responsive” in “bulk” e in forma di “coating”, processi di “manufacturing” a basso consumo energetico (processo di electro-curing), processi di Additive Manufacturing (3D printing), processi di elettro-filatura per l’ingegneria tissutale e biomedicale (electro-spinning).
- Progettazione e Sviluppo di materiali vetro-ceramici a partire da materiali di scarto industriali; sintesi di materiali attraverso la tecnica sol-gel (catalizzatori, biosensori, coating di film sottili su materiali metallici e polimerici)
- Progettazione e Sviluppo di geopolimeri (materiali allumino-silicatico) utilizzati come adesivi per la realizzazione di rinforzi strutturali su edifici in muratura; come catalizzatori per l’ottenimento di mattoni a bassa energia; come nuovi cementi e laterizi a basso impatto industriale sfruttando rifiuti speciali come le “FlyAsh”.
Responsabile: Michelina CATAURO
Partecipanti: Luigi VERTUCCIO (RTDB), Antonio D’ANGELO (PhD); Veronica VIOLA (PhD); Anna Maria PICCIRILLO; Luigi COSTANZO; Liberata GUADAGNO; Marialuigia RAIMONDO; Raffaele LONGO; Elisa CALABRESE; Francesca ALIBERTI; Roberto PANTANI.
Laboratorio di riferimento:
Smart Production and Logistics Systems - Sistemi intelligenti di produzione e logistica
Descrizione linee di ricerca: Competenza principale del gruppo di ricerca è l’impiego di metodi e tecnologie digitali dell’ambito della produzione manifatturiera discreta per la definizione di nuovi scenari e sistemi di produzione e logistica industriale che traggano beneficio (in termini di sostenibilità e resilienza) dall’uso integrato di tecnologie abilitanti e metodi della progettazione e gestione degli impianti industriali singoli ed in rete. Molti aspetti innovativi legati alla progettazione e gestione di impianti industriali (e delle loro reti) sono connessi alla loro modellizzazione digitale e alla loro integrazione con le tecnologie abilitanti anche sviluppate in altri ambiti della conoscenza non immediatamente riconducibili al mondo dell’industria manifatturiera (ad esempio: intelligenza artificiale, block chain, etc.). Nella sostanza, il gruppo di ricerca è in grado di sviluppare metodi e prototipi di sistema che validino l’utilizzo di una particolare tecnologia abilitante per affrontare uno specifico problema operativo nell’ambito della produzione e della logistica dei singoli impianti e delle loro reti. Un tale approccio integrato alla progettazione e alla ottimizzazione di sistemi produttivi (e delle loro reti), favorisce la possibilità di validare in laboratorio (TRL4) metodi e tecnologie innovative per lo sviluppo di nuovi paradigmi e organizzazioni della produzione e della logistica industriale, nonché di dimostrarle in ambienti industrialmente rilevanti (TRL5) grazie ai numerosi partner industriali con cui il gruppo di ricerca vanta collaborazioni più che decennali.
Responsabile: Roberto MACCHIAROLI
Partecipanti: Marcello FERA; Ciro NATALE; Marta RINALDI; Mario CATERINO; Alessandro GRECO.
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Robotica
Smart Water Systems Optimization And Protection - Ottimizzazione E Protezione Dei Sistemi Idrici Intelligenti
Descrizione linee di ricerca: Il gruppo di ricerca lavora da anni sull’ottimizzazione del dimensionamento e della gestione delle infrastrutture idrauliche ed ambientali con particolare riguardo agli aspetti del risparmio idrico ed energetico ed alla protezione qualitativa e quantitativa della risorsa idrica. I componenti del gruppo di ricerca sono coinvolti nell’ambito di diversi progetti di ricerca di interesse sia nazionale (PRIN) che comunitario (HORIZON) e in attività di consulenza/convenzione con diversi enti nazionali ed internazionali. I principali temi di ricerca portati avanti riguardano: la gestione dei serbatoi artificiali, la bonifica delle falde inquinate, la gestione delle pressioni idriche, il partizionamento automatico delle smart water network, l’analisi di rischio e lo sviluppo di tecnologie e best practice per l’ottimizzazione delle infrastrutture idrauliche. I programmi di ricerca si avvalgono sia dell’utilizzo della modellazione numerica che della sperimentazione su modello fisico. A tale riguardo il gruppo utilizza le attrezzature presenti nel dipartimento di afferenza tra cui oltre un sito pilota a Pozzuoli costituito da una parte di rete idrica di distribuzione dotata di strumentazioni di misura e controllo nonché attrezzature sperimentali acquisite con i fondi del progetto di Ateneo VALERE. Il gruppo di ricerca collabora con diversi centri di ricerca ed istituzioni nazionali ed internazionali, ha partecipato a diversi progetti di ricerca italiani (PON, POR, PRIN, etc.) ed europei (INTERREG), ha pubblicato numerosi lavori su prestigiose riviste internazionali partecipando inoltre a numerosi convegni sui temi della sostenibilità ambientale e dell’ottimizzazione delle risorse idriche. Il gruppo è fortemente orientato allo sviluppo di tecnologie, il responsabile scientifico è stato leader dell’Action Group (denominato CTRL+SWAN: Cloud Technologies & ReaL time monitoring + Smart WAter Network) dell’European Innovation Partnerships on Water ed è attualmente leader del Working Group WATER-SET del consorzio europeo Water Europe con il quali ha avviato collaborazioni di ricerca con numerose università, centri di ricerca, startup ed aziende leader mondiali nella gestione ottimale delle risorse idriche e della sensoristica. Alcuni componenti del gruppo di ricerca hanno realizzato e registrato il copyright internazionale del software Smart WAter Network Partitioning and Protection (SWANP©). Inoltre il gruppo di ricerca ha attive numerose convenzioni con water utilities ed enti per la gestione ottimale delle reti idriche.
Le principali linee di ricerca sono le seguenti:
- Ottimizzazione della gestione di serbatoi artificiali per superare i periodi di siccità
Al primo tema si riferiscono le ricerche svolte nel campo dell’ottimizzazione della gestione dei serbatoi artificiali, in particolare lo studio di tecniche per sistemi di supporto alle decisioni – utilizzando approcci di ottimizzazione metaeuristica basati sulla logica fuzzy e gli algoritmi genetici – in grado di gestire automaticamente, mediante appositi sistemi di decisione e controllo, il rilascio dei volumi di un invaso artificiale nelle diverse condizioni di esercizio (ordinarie e di siccità) valutate mediante l’ausilio di tecniche di identificazione e previsione di processi stocastici (AR, ARX, ARMA, etc.) e di simulazione tipo Montecarlo. In tale linea di ricerca si inseriscono studi volti a mitigare gli impatti dei periodi di siccità anche mediante tecniche predittive di machine learning.
- Analisi, ottimizzazione e protezione delle reti di distribuzione idriche nel nuovo contesto delle smart water network
Al secondo argomento si riferiscono le ricerche condotte sui sistemi idrici di distribuzione. In particolare – dopo aver indagato gli effetti dell’alterazione delle performance idrauliche delle reti dovute all’applicazione della metodologia della distrettualizzazione, sia ai sensi del D.M. n°99 del 1997 che del D.Lgs. 152/2006 e delle recenti Delibere ARERA, che delle indicazioni delle principali organizzazioni internazionali (IWA; AWWA; etc.) e le opportunità offerte dalla gestione delle pressioni per la diminuzione delle perdite di una rete di distribuzione idrica - sono state sviluppate tecniche ottimali per il partizionamento automatico delle reti basate su procedure di ottimizzazione metaeuristica della definizione dei distretti idrici e del grado di regolazione delle valvole per la gestione delle pressioni. A tal fine, partendo dalla teoria dei grafi e dalle tecniche di partizionamento dei grafi utilizzate in Informatica per la distribuzione delle mesh di calcolo ai processori, sono state sviluppati originali algoritmi basati sull'accoppiamento di tecniche di simulazione idraulica (anche con approccio pressure driver), di algoritmi evolutivi (algoritmi genetici, algoritmi delle formiche) e tecniche di partizionamento dei grafi. In particolare nell’ambito del tema delle Smart Water Network, sono in corso di sviluppo ricerche per la definizione di metodologie, criteri ed algoritmi, mutati dalla Complex Network Theory, per una migliore comprensione delle relazioni tra topologia, resilienza e robustezza delle reti idriche al fine di migliorarne la progettazione, la gestione e il partizionamento in distretti. Inoltre nell’ambito della gestione ottimale delle reti acquedottistiche sono state inoltre sviluppate tecniche di identificazione della legge di domanda e di perdita, di distribuzione spazio temporale della domanda ed è stato realizzato un sito pilota dove sono state condotte attività sperimentali per la calibrazione dei modelli e la validazione delle tecniche proposte.
- Modellazione idrodinamica e geochimica degli acquiferi sotterranei per la bonifica dei siti contaminati
Con riferimento al terzo argomento, la ricerca è stata indirizzata allo sviluppo di tecniche di modellazione idrodinamica delle falde e di sistemi permeabili (barriere idrauliche) per lo studio della bonifica di siti contaminati con tecnologie innovative (PRB/Dreni adsorbenti). La modellazione è incentrata anche sullo studio della dispersione dei contaminanti in falda, al fine di valutare gli effetti dei principali parametri idrodinamici ed idrologici, tra cui la conducibilità idraulica e la diffusione, ad esempio, sull’andamento spazio-temporale dei contaminanti disciolti. Inoltre, sono sviluppati modelli che tengono in conto l’interazione suolo-falda al fine di valutare l’effetto che la naturale attenuazione del suolo ha sulla dispersione dei contaminanti disciolti in relazione, ad esempio, al fenomeno di “tailing and rebound”. In questa linea si inserisce anche la valutazione geochimica delle matrici ambientali, in particolare delle forme geogeniche di contaminazione oltre a quelle antropiche. Lo studio dell’interazione acqua-gas-roccia con particolare riferimento al rilascio di metalli e metalloidi è parte integrante della strategia di ricerca per la definizione del fondo geochimico locale. La valutazione geochimica delle matrici ambientali (acqua, suolo e anche aria) è oggetto di ricerca in particolare per quanto concerne le forme geogeniche di contaminazione. La particolarità del territorio campano, ovvero la sua natura vulcanica in parecchi distretti geologici necessita dello studio dell’interazione acqua-gas-roccia con particolare riferimento al rilascio di metalli e metalloidi e come parte integrante della strategia per la definizione del fondo geochimico locale. Si vuole infatti stimare al netto di contaminazioni antropogeniche il contributo naturale dovuto al fondo geochimico al fine di dedurre i principali parametri chimico-fisici dei processi di dissoluzione minerale oltre alle caratteristiche litologiche (ad es. per infiltrazione di CO2 profonda) e ottenere utili indicatori sullo stato termico e geochimico di tali sistemi. Le finalità dello studio comprendono la valutazione della vulnerabilità geochimica dei corpi idrici, la valutazione del potenziale geotermico e una migliore comprensione dei fenomeni geofisici in atto in alcuni settori regionali (ad es. bradisismo dei Campi Flegrei). Poiché l’idrotermalismo e i suoi effetti rappresentano un aspetto saliente dello studio proposto, si effettuano comparazioni e studi di altri sistemi pertinenti ai contesti geodinamici caratterizzato da idrotermalismo, in particolare negli ambienti di subduzione e per i quali si dispongono comunque dati sui corpi idrici sotterranei di interesse geotermico. Le relazioni con le forme di rischio naturale del territorio sono anche considerate nello studio.
Responsabile: Armando DI NARDO
Partecipanti: Simeone CHIANESE; Roberto GRECO; Roberto MORETTI; Dino MUSMARRA; Giovanni Francesco SANTONASTASO.
Laboratorio di riferimento: Laboratory of Architecture and Building Technologies (LABTech), Laboratorio di Idraulica e Idraulica Marittima
Structural Health Monitoring - Monitoraggio dell’integrità strutturale
Descrizione linee di ricerca:
Il gruppo di ricerca mira alla costituzione di una comunità interdisciplinare finalizzata allo sviluppo, integrazione e implementazione di sistemi automatici ed intelligenti volti al monitoraggio e alla prognosi, in tempo reale, delle condizioni di salute delle strutture. Molti dei vantaggi indotti dalla realizzazione di strutture leggere, quali migliori prestazioni, riduzione della Carbon footprint e ridotto consumo di inquinanti, non possono essere conseguiti senza una strategia che miri all’impiego di materiali intelligenti in grado di auto-monitorare le proprie condizioni di salute. Il gruppo di ricerca lavora allo sviluppo di sistemi intelligenti volti ad una più efficiente gestione della salute in tempo reale delle strutture, promuovendo l’impiego di tecniche di controllo non distruttive e sensoristica avanzata, opportunamente integrate con tecniche di intelligenza artificiale, per l’elaborazione e l’interpretazione dei dati acquisiti e per la definizione di una strategia di valutazione dei danni. L’intelligenza artificiale svolge un ruolo cruciale nella progettazione dei sistemi de monitoraggio, consentendo di processare grandi moli di dati, registrati dalla rete di sensori di cui si serve la struttura, superandone le incertezze associate. Le attività intraprese dal gruppo, grazie anche alla collaborazione con i numerosi partner industriali e centri di ricerca, favoriscono la possibilità di sviluppo di invenzioni con TRL 4-5 tali da poter confluire in domande di brevetti nazionali ed internazionali. Il cuore operativo del Gruppo di Ricerca si colloca presso il Laboratorio di Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine del Dipartimento di Ingegneria.
Responsabile: Alessandro DE LUCA
Partecipanti: Aldo MINARDO; Alessandro GRECO; Antonio AVERSANO; Antonio POLVERINO; Donato PERFETTO; Francesco CAPUTO; Luciano PIANESE; Nima REZAZADEH; Raffaele SEPE; Raffaele VALLIFUOCO; Ester CATALANO.
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine.
Structural & Wind Engineering - Ingegneria Strutturale e del vento
Descrizione linee di ricerca: Il Gruppo di Ricerca in Ingegneria Strutturale e del Vento sviluppa attività di ricerca teorica ed applicata, così come svolge attività di consulenza, che possono essere raggruppate nelle seguenti linee di ricerca.
- Meccanica dei materiali, dei suoli e strutture civili
Il gruppo di ricerca S&WE svolge ricerca teorica e applicata su aspetti di meccanica dei materiali, delle terre e delle strutture civili. Il gruppo si occupa di metodi risolutivi per problemi di plasticità, stabilità e meccanica della frattura di materiali omogenei ed eterogenei, con enfasi sull’analisi isogeometrica applicata al metodo degli elementi di contorno. Reti neurali artificiali ed altre tecniche avanzate di ottimizzazione vengono utilizzate in problemi di identificazione strutturale. Vengono svolte indagini sperimentali e teoriche sul comportamento dei terreni sia alla scala REV attraverso test di laboratorio (Laboratorio di Dipartimento), sia a piccola scala e scala reale mediante modellazione fisica (Laboratorio di Dipartimento e laboratori avanzati di istituzioni internazionali). Sulla base dell’esperienza sperimentale, vengono sviluppati modelli costitutivi ed applicati nel campo della geomeccanica. Vengono sviluppati ed implementati modelli di ordine superiore in grado di riprodurre con maggiore accuratezza il comportamento fenomenologico di strutture complesse, e di comprendere i limiti naturali associati ai modelli classici della trave di Bernoulli e della piastra di Kirchooff. Ciò consente una più accurata ricostruzione del campo tensionale. Vengono trattati problemi di interazione fluido-struttura, sia nel campo dell’ Ingegneria del Vento, sia relativi all’interazione dell’acqua con infrastrutture e condotte e all’interazione di fluidi biologici con i tessuti.
2. Comportamento dinamico e stabilità di terreni e strutture
Il gruppo di ricerca S&WE ha competenze sul comportamento dinamico di terreni, strutture ed elementi strutturali, sui loro meccanismi di carico e di risposta. La risposta di terreni a carichi dinamici viene indagata con prove di laboratorio a scala dell’elemento, e teoricamente con modelli di risposta di ampie porzioni di terreno. Viene trattata la liquefazione dei terreni in depositi sabbiosi sotto carichi ciclici, e vengono proposti metodi per valutarne l’occorrenza e strategie di mitigazione del rischio. Vengono affrontati problemi di interazione suolo-struttura. Nello studio dell’impatto contro strutture e dispositivi di ritenzione vengono utilizzati modelli dettagliati agli elementi finiti di veicoli stradali. Questi, validati secondo la EN 16303, vengono utilizzati per riprodurre risultati di test al vero e per studiarne l’urto contro le barriere stradali installate in condizioni non ordinarie. Si tratta anche l’analisi dei carichi d’urto su materiali e strutture da ponte. I carichi dovuti ai singoli pedoni ed alle folle sono modellati dal punto di vista deterministico e probabilistico. Vengono svolte analisi di affidabilità di passerelle pedonali snelle. Vengono affrontati problemi di stabilità delle strutture in acciaio ed alluminio, con particolare attenzione agli effetti di imperfezioni meccaniche e geometriche combinate con il comportamento plastico del materiale. Viene studiata la stabilità aerodinamica di strutture civili snelle.
3. Analisi e progettazione delle strutture civili
Il gruppo di ricerca S&WE si occupa principalmente della progettazione di fondazioni profonde, strutture per ponti ed edifici, silos e serbatoi. Il gruppo ha una lunga esperienza nella analisi e progettazione di fondazioni profonde in condizioni di carico generico. Ha messo a punto una metodologia di progettazione ottimizzata di gruppi di pali che consente una notevole riduzione di costi, in particolar nel caso delle turbine eoliche. Nell’ambito della ingegneria dei ponti, vi è esperienza nella progettazione, collaudo e consolidamento di ponti in c.a., acciaio e misti. In particolare, il gruppo è impegnato nella valutazione dei ponti esistenti, con lo scopo di valutarne la vulnerabilità nei confronti del traffico stradale e di azioni climatiche e sismiche. L’esperienza nella progettazione strutturale riguarda la valutazione e retrofit di strutture edili, con particolare riguardo alla applicazione dei principi del Performance Based Design di strutture in c.a. ed acciaio. E’ stata acquisita una importante esperienza sulla valutazione e adeguamento di strutture in muratura non armata. Il gruppo ha una consolidata esperienza nella valutazione e progettazione di strutture in acciaio ed alluminio, con particolare enfasi nella progettazione e valutazione delle prestazioni di strutture intelaiate in acciaio nei confronti del collasso progressivo, anche conformi ai requisiti sismici. Viene affrontata la progettazione di serbatoi metallici e silos in diverse condizioni di lavoro.
4. Affidabilità e costruzioni sostenibili
Tra le sfide dei prossimi decenni vi è quella della riqualificazione del patrimonio edilizio ed infrastrutturale. Con riferimento all’Unione Europea, la maggior parte delle opere di Ingegneria Civile risale alla seconda metà del Novecento, e soffre di vetustà ed inadeguatezza. La ristrutturazione di tali opere richiede il rispetto dei più recenti standard in termini di affidabilità, resilienza e sostenibilità, anche in vista dei cambiamenti avvenuti ed attesi nella società e nell’ambiente naturale, e delle loro più stringenti richieste. Gli impatti dei cambiamenti climatici sono, e lo saranno sempre di più in futuro, una sfida per l’ambiente edificato e gli scenari per la loro evoluzione devono essere presi in considerazione quando vengono realizzate nuove costruzioni e quelle esistenti vengono rinnovate. In tale scenario, il gruppo di ricerca S&WE ha un crescente interesse per gli aspetti legati alla affidabilità delle strutture in particolare, e delle costruzioni civili in generale, quando esposte alle azioni climatiche e a quelle di altra natura. Basandosi su una modellazione probabilistica delle variabili climatiche e della loro interazione con le costruzioni, vengono effettuate analisi specifiche ed adottate procedure di calibrazione delle normative strutturali. In aggiunta, nella progettazione e nel retrofit delle strutture vengono indagati in maniera specifica approcci e tecniche basati sui principi di sostenibilità e reversibilità.
5. Ingegneria del Vento
Vengono svolte ricerca e forniti servizi di consulenza nell’ampio dominio dell’Ingegneria del Vento, a partire dagli studi di base nei campi della meteorologia e della fisica dell’atmosfera, fino alle applicazioni alla ingegneria strutturale e all’energia eolica. In particolare, il gruppo di ricerca S&WE ha competenze sui seguenti temi:
- Analisi del clima eolico
- Fluidodinamica dello strato limite atmosferico
- Aerodinamica delle costruzioni
- Azione ed effetti del vento sulle strutture
-
Vibrazioni indotte dal vento su strutture snelle e comportamentoaeroelastico
-
Progettazione di strutture esposte al vento
-
Prove in galleria del vento e monitoraggio di strutture esposte al vento
-
Progettazione ambientale
-
Energia eolica onshore e offshore
Il Gruppo di ricerca S&WE ha una lunga esperienza nella redazione di normative sulle azioni da vento, nel loro uso nell’ambito della progettazione strutturale e nella loro integrazione con studi ad hoc. Vengono, inoltre, trattati gli aspetti legati alla affidabilità delle costruzioni esposte al vento. Gli studi dell’impatto del vento sulla pianificazione urbanistica, progettazione architettonica ed ambientale vengono effettuati attraverso software di modellazione quale ENVI-met. Vengono effettuati studi sul comfort degli spazi urbani aperti finalizzati a soluzioni più sostenibili, nonché studi sull’impatto del vento su arredi urbani ed elementi architettonici
Responsabile: Francesco RICCIARDELLI
Partecipanti: Alberto Maria AVOSSA; Emilia DAMIANO; Raffaele DI LAORA; Luca ESPOSITO; Alberto MANDARA; Vincenzo MINUTOLO; Lucio OLIVARES; Mariano PERNETTI; Eugenio RUOCCO; Renata VALENTE; Andac AKBABA; Roberto BOSCO; Raffaele CESARO; Martina DE CRISTOFARO; Habib HIMANI; Nunzia LETIZIA; Antonio MALASOMMA; Denise MANNA; Erika MOLITIERNO; Simone PALLADINO; Vincenzo PICOZZI; Renato ZONA.
Territorial Intelligence as Engine for Sustainable Development - L’intelligenza territoriale come propulsore di sviluppo sostenibile
Descrizione linee di ricerca:
1 ͣ linea di ricerca: La rigenerazione urbana e sociale.
La rigenerazione urbana e sociale intende evidenziare le criticità mese in campo dalla dimensione medioglobale dove sono state messe in discussione le funzioni semantiche degli scenari urbani e sociali. La pianificazione delle città deve, infatti, relazionarsi con i cambiamenti sociali, economici e culturali che investono le comunità contemporanee. Rigenerare il contenuto di senso dell’ambiente costruito è il punto di partenza e l’obiettivo ultimo di ogni progetto che intenda superare le resistenze che l’ambiente ha creato. Il ridisegno del costruito, inteso come dato reale e tangibile, deve necessariamente partire, in funzione rigenerativa, dall’immaterialità delle strutture antropiche. Ridisegnare l'URbano a partire dalle nuove forme di socialità inclusive e prospettiche può attivare processi disseminativi dell'Intelligenza Territoriale. In particolare potrebbe essere utile diffondere orientamento all’utilizzo di tecnologie informatiche al fine di creare e applicare nuovi modelli comunicativi nonché organizzativi e gestionali; promuovere cultura d’impresa e non solo relativamente all’aspetto dell’organizzazione e della gestione delle risorse umane; potenziare e coinvolgere tutte le risorse del territorio capaci di interconnettersi e generare sinergie.
2 ͣ linea: Analisi delle emergenze
La rigenerazione territoriale può essere intesa come modello analitico e progettuale replicabile in più contesti. Il ridisegno del territorio nell’ottica dello sviluppo sostenibile è infatti necessario non solo al fine di potenziare le risorse valoriali, qualitative e quantitative che insistono sui territori ma anche al fine di valutarne la resilienza o la resistenza ossia la loro capacità di adeguarsi ai molteplici cambiamenti che li rendono più vulnerabili o ne condizionano la crescita. Il modello di rigenerazione può essere applicato dunque sia ai territori resilienti ossia capaci di dare risposte in termini sociali economici e ambientali ai bisogni dei cittadini sia a quelli resistenti ossia quelli che vivono una condizione di crisi permanente e sono incapaci di offrire soluzioni. Come caso-studio è possibile prendere in considerazione la parte del territorio campano individuato nell’ultimo periodo come “terra dei fuochi” e che rappresenta sicuramente nello scenario nazionale - e forse anche europeo - una reale emergenza.
Focus tematici del gruppo di ricerca:
1. L’ambito è quello del territorio/città intelligente. Inclusività e adattamento ai cambiamenti vanno modulati al fine di ottimizzare gli investimenti nel sociale. In quest’ambito:
- Rigenerazione territoriale
- Questioni di genere
- Giovani
- Istruzione
- Conoscenza, sono funzionali alla riduzione dei rischi e delle situazioni di emergenza.
2. Rigenerazione territoriale e urbana: progettare la società circolare.
Responsabile: Annamaria RUFINO
Partecipanti: Salvatore LOSCO, Massimiliano RENDINA, Armando DI NARDO
TheLabs-Thermal-Laboratories - Gruppo di Trasmissione del Calore ed Efficienza Energetica
Descrizione linee di ricerca:
Le attività di ricerca sviluppate dal gruppo sono relative alla Trasmissione del Calore ed alla Efficienza Energetica negli edifici e nei processi industriali e si possono raggruppare nelle linee di ricerca:
Trasmissione del Calore
Si sviluppano attività di ricerca di base e applicata nei settori: delle micro e nanotecnologie, quali film sottili, nanofluidi, microcanali e nanocanali; mezzi porosi, con particolare riferimento alle schiume metalliche ottenute con processo classico o con l’additive manufacturing; delle tecnologie dei trattamenti e lavorazioni mediante laser.
Con l’esperienza acquisita nel corso degli anni, si sviluppa al meglio le capacità di progettazione e ottimizzazione termiche di sistemi e componenti in generale e in particolare di componenti e sistemi elettronici per il loro controllo termico, di componenti e la sicurezza negli edifici, compreso quegli storici, ad uso collettivo e delle infrastrutture.
Conversione dell'energia e Risparmio energetico
Un particolare interesse è rivolto alla termofluidodinamica per la climatizzazione degli ambienti, al risparmio energetico e al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, alla sicurezza degli edifici storici e delle infrastrutture.
Sistemi per la conversione dell’energia soprattutto per le fonti alternative e rinnovabili.
Attività finalizzata al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, per la climatizzazione degli ambienti, per il risparmio energetico e dei sistemi di accumulo di energia termica sia latente sia sensibile.
Responsabile: Sergio NARDINI
Partecipanti: Oronzio MANCA ; Bernardo BUONOMO; Furio CASCETTA; Alessandro MAURO; Aanandsundar ARUMUGAM; Atiqur REHMAN FAREEDI; Maria Rita GOLIA; Hurmat KHAN; Abdul QADEER KHOSO; Chandra KRISHNA; Renato Elpidio PLOMITALLO; Safa SABET; Gianluca SARLI; Luigi MENDITTO; Assunta ANDREOZZI; Nicola BIANCO ; Vincenzo BIANCO; Wilson K. S. CHIU; Alina A. MINEA; Yogesh JALURIA; Kambiz VAFAI; Michele FERRAIOULO; Daniele RICCI; Salvatore TAMBURRINO; Huseyin KAYA.
Laboratorio di riferimento: Laboratorio di Trasmissione del Calore